Questa primavera la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha annunciato la volontà di ridurre gradualmente i test sugli animali per lo sviluppo di nuovi farmaci. Finora, sia negli USA sia in Europa, prima di essere testate sugli esseri umani le molecole dovevano essere impiegate in almeno due specie animali, per ridurre la probabilità di possibili effetti avversi e tossicità nell’uomo. L’impiego di due specie animali, infatti, evita di basarsi su una sola fisiologia che potrebbe non riflettere adeguatamente quella umana.
L’European Medicines Agency (EMA) in questo momento è più cauta, sebbene supporti una legislazione che vada verso un minor impiego di cavie animali. A livello europeo, una direttiva del 2010 impone infatti le cosiddette 3R: Replacement (sostituire l’animale quando possibile), Reduction (limitare il numero di esemplari utilizzati) e Refinement (migliorare le condizioni sperimentali per ridurre la sofferenza).
Negli ultimi anni l’agenzia europea promuove un approccio graduale ai metodi alternativi, a partire da aree tossicologiche specifiche.
Nel 2023, la Commissione europea ha annunciato un piano per eliminare gradualmente i test animali nelle valutazioni di sicurezza chimica.
Modelli complementari
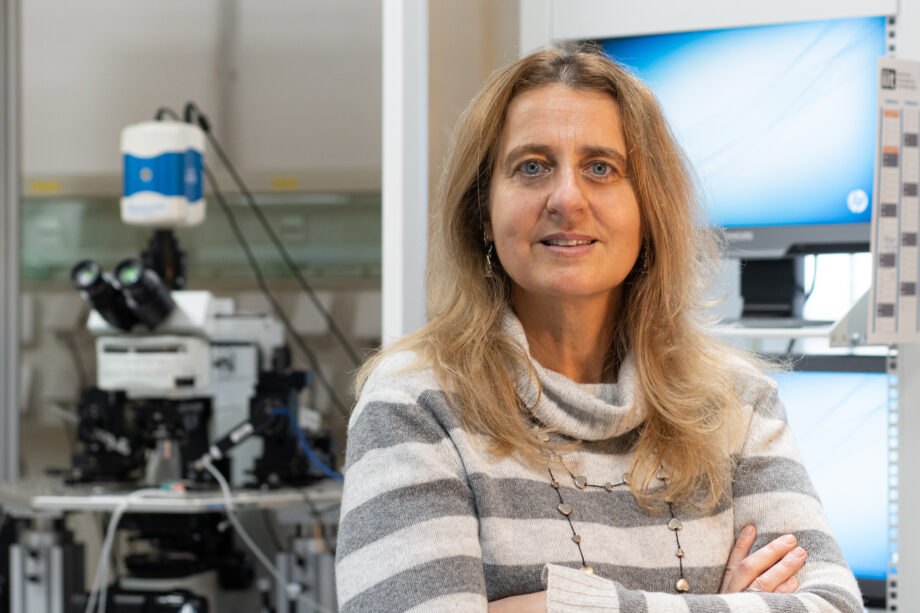
«Non parlerei di metodi alternativi, ma complementari. Ad oggi resta impensabile, nella ricerca scientifica, pensare di sostituire completamente la sperimentazione animale con altri modelli». Silvia Di Angelantonio è docente di Fisiologia a Sapienza Università di Roma e ricercatrice all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Ha recentemente pubblicato uno studio su un farmaco anti-colesterolo che potrebbe essere utilizzato come terapia nella demenza frontotemporale, una forma rara a esordio precoce e molto aggressiva.
L’efficacia del bezafibrato – questo il nome della molecola – è stata dimostrata senza coinvolgere animali: i test di laboratorio sono stati infatti eseguiti interamente su organoidi cerebrali. Come suggerisce il nome, si tratta di mini-organi che si autoassemblano a partire da cellule staminali e mimano alcune funzioni. «Abbiamo scelto gli organoidi perché lo abbiamo ritenuto il modello più adatto per indagare il neurosviluppo – spiega Di Angelantonio -. Stavamo studiando una mutazione del gene tau che causa la demenza frontotemporale e avevamo osservato problemi già nelle prime fasi dello sviluppo neuronale». In questo caso gli organoidi hanno riprodotto alcune caratteristiche tipiche della patologia: perdita di connessioni tra i neuroni, ridotta attività funzionale e accumulo della proteina tau patologica.
Dalla provetta all’organoide: una rivoluzione in pochi decenni
«Quando ho iniziato a fare ricerca lavoravamo con i modelli animali. Era la norma, e spesso se ne usavano tantissimi», racconta Maurizio Muraca, coordinatore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP) di Padova.
Grazie agli organoidi è possibile sperimentare nuovi farmaci in condizioni più vicine alla realtà umana
Col tempo, però, la scienza ha fatto passi da gigante: dagli enzimi in provetta, allo studio delle cellule, fino a tentare di ricostruire il loro ambiente naturale. Il progresso ha portato alla nascita degli organoidi, che sono strutture tridimensionali che riproducono in laboratorio le unità funzionali di un organo. Grazie a queste “miniature biologiche” oggi è possibile osservare, con una precisione mai raggiunta prima, le dinamiche cellulari e sperimentare nuovi farmaci in condizioni molto più vicine alla realtà umana rispetto ai modelli animali.
Cosa succede oltreoceano
Nell’aprile 2025, l’FDA ha pubblicato un documento strategico intitolato Roadmap to Reducing Animal Testing in Preclinical Safety Studies, con l’obiettivo di integrare e – dove possibile – sostituire l’uso di animali nei test di sicurezza preclinica con le cosiddette New Approach Methodologies (NAMs).
L’agenzia ha annunciato che comincerà con i farmaci biologici, in particolare gli anticoropi monoclonali. Le integrazioni all’uso degli animali comprendono modelli computazionali basati su intelligenza artificiale, sistemi in vitro come per esempio organoidi e dati real-world (questi ultimi da utilizzare nei casi in cui un farmaco sia già stato studiato in altri Paesi con standard regolatori comparabili).
L’obiettivo è che tra 5 anni l’uso di animali per scopi scientifici sia l’eccezione e non la regola.
L’FDA vuole ridurre l’uso di animali nella sperimentazione scientifica nei prossimi 5 anni
Nel 2022 l’allora presidente degli Stati Uniti John Biden firmò una legge per rimuovere il requisito obbligatorio che in molti casi imponeva l’uso di test animali nei passaggi preclinici di sviluppo e approvazione dei farmaci. Da quel momento in poi, il ricorso a test su animali non è più obbligatorio: si possono utilizzare metodi alternativi purché dimostrino di essere adeguati a livello di sicurezza e efficacia.
I vantaggi degli organoidi
Gli organoidi offrono tre grandi vantaggi: fedeltà biologica, riproducibilità ed etica. Derivando da cellule umane, superano molte delle differenze esistenti con il metabolismo animale. In secondo luogo, se ne possono produrre centinaia, testando così diverse condizioni sperimentali in parallelo. Infine, gli aspetti etici: riducono il ricorso agli animali da laboratorio, un tema sempre più sensibile anche a livello normativo.

Nonostante questo, Muraca avverte, trovandosi così d’accordo con Di Angelantonio: «Non credo che elimineranno del tutto la sperimentazione animale. Alcune domande riguardano l’organismo nel suo insieme, e lì serve ancora un modello complesso. Ma stiamo andando verso sistemi sempre più integrati, grazie alla bioingegneria e alla microfluidica, capaci di collegare tra loro diversi organoidi e simulare funzioni complesse come la circolazione portale tra intestino e fegato».
Come già accennato, poi, gli organoidi aprono possibilità impensabili soprattutto nello studio di malattie genetiche rare e del neurosviluppo. «Possiamo prendere cellule della pelle o persino dalle urine di un bambino, riportarle allo stato di staminali, quindi totipotenti, e guidarle a formare un micro-cervello. Così possiamo osservare passo passo come un gene difettoso influisce sullo sviluppo cerebrale. È un salto enorme per capire la patogenesi e immaginare nuove terapie», spiega Muraca.
Limiti e sfide per il futuro
«Non possiamo far finta che il nostro cervello sia esente dalla regolazione immunitaria o da quella ormonale, oppure dall’effetto dei farmaci o da ciò che mangiamo», ricorda Di Angelantonio.
Oltre alla limitata complessità, poi, gli organoidi utilizzati dal gruppo di Di Angelantonio sono al momento privi di vascolarizzazione, fatto che ne limita dimensione e maturazione e mancano di alcuni elementi importanti, per esempio le microglia, le cellule immunitarie residenti del cervello, cruciali sia per la difesa sia per la regolazione delle sinapsi. «Oggi stiamo iniziando a integrare microglia generate a parte, proprio per rendere il modello più completo – afferma la ricercatrice -. È una direzione di ricerca fondamentale».
Organizzazione e capitale umano
C’è poi il nodo delle risorse: coltivare organoidi richiede mezzi di coltura costosi, fattori di differenziamento specifici, incubatori dedicati, bioreattori e cappe speciali con microscopi integrati. «È una ricerca più costosa e più impegnativa rispetto alla tradizionale – sostiene Di Angelantonio -. Servono fondi, infrastrutture, ma soprattutto capitale umano formato».
Un esempio? Per ottenere risultati solidi occorrono lunghi tempi di coltura: l’ultimo lavoro del gruppo ha utilizzato organoidi di 100 giorni, seguiti quotidianamente. «La differenza la fanno anche i giovani ricercatori: dottorandi e post-doc che hanno voglia di investire energie, persino venendo in laboratorio la domenica. Senza di loro non avremmo raggiunto questi risultati».
È importante investire (e trattenere) capitale umano formato
Sul capitale umano concorda anche Muraca: «La vera sfida è trattenere i giovani ricercatori. Formarli richiede anni e passione, ma senza investimenti adeguati nel capitale umano rischiamo di perderli. Ed è un trauma per tutto il sistema. Per quella che è la mia esperienza – continua l’esperto – non credo che sia più costosa la sperimentazione con organoidi rispetto a quella animale, semmai una volta che hai la metodologia in mano è vero il contrario. I costi importanti sono in termini di acquisizione e sviluppo della tecnologia e formazione, appunto».
Tumoroidi e medicina personalizzata: la nuova frontiera
Accanto agli organoidi “sani”, la ricerca si sta interessando anche ai tumoroidi, ottenuti da cellule tumorali del paziente. Queste strutture tridimensionali permettono di testare in vitro i chemioterapici, offrendo indicazioni molto più vicine alla realtà clinica rispetto alle colture bidimensionali.
Il passo successivo? Integrare tumore e tessuto ospite per capire come il microambiente favorisca o ostacoli la progressione della malattia. Qui entra in gioco la medicina personalizzata: «Non ci interessa tanto sapere che tumore ha il paziente, ma che paziente ha quel tumore. È un concetto che risale addirittura a Ippocrate», ricorda Muraca.
I tumoroidi aprono nuove frontiere verso la medicina personalizzata
E poi ci sono le patologie rare, magari quelle particolarmente difficili da studiare, come i difetti cerebrali del neurosviluppo: «Gli organodi ci permettono non soltanto di avere un microorgano, ma di studiare le varie fasi che portano allo sviluppo dell’organo stesso. Quindi, per esempio, capire quando un gene si esprime in modo patologico durante lo sviluppo del cervello. Questo ha delle implicazioni enormi nella comprensione della fisiopatologia e potenzialmente nella cura di queste malattie», conclude il coordinatore Scientifico dell’IRP.





