A 47 anni dall’approvazione della legge che ha trasformato radicalmente l’approccio alla malattia mentale in Italia, segnando la chiusura dei manicomi, la contenzione meccanica resta una pratica diffusa nel nostro Paese. Consiste nel legare le persone al letto qualora si manifesti una forte aggressività o in situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
Quantificarne la diffusione, tuttavia, rimane complesso: i dati disponibili sono scarsi e non accessibili al pubblico. Questo fenomeno infatti, oltre a essere poco conosciuto, è anche carente di un monitoraggio sistematico. Eppure, nel 2021 l’allora Ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva stanziato 60 milioni di euro per potenziare i Dipartimenti di Salute Mentale proprio con l’obiettivo, tra gli altri, di superare l’uso della contenzione meccanica. La bozza di accordo è stata approvata in Conferenza Stato-Regioni nell’aprile 2022, ma i risultati di questa iniziativa restano difficili da valutare.
A 47 anni dalla chiusura dei manicomi, la pratica della contenzione meccanica è usata nella stragrande maggioranza dei reparti di Psichiatria
Tra gli elementi disattesi c’è proprio il monitoraggio dei risultati raggiunti: l’attuazione dei progetti terminava a giugno 2024 ed entro dicembre le Regioni avrebbero dovuto trasmettere un report delle attività svolte. A fine 2024, secondo quanto riportato da Ludovica Jona, giornalista autrice di un’inchiesta sul tema, solo 10 Regioni sulle 15 che avevano ricevuto i finanziamenti hanno inviato i risultati. Non lo hanno fatto Lombardia, Lazio, Puglia, Molise e Sicilia.
I numeri
Sempre Jona, a luglio 2024 ha chiesto alle Regioni – tramite una serie di istanze di accesso agli atti – i numeri delle contenzioni. Solo in 12 hanno fornito i dati, relativi al 2022: quell’anno, in queste Regioni ci sono state 7.534 contenzioni. Questa cifra si riferisce ai soli SPDC (i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che si trovano all’interno degli ospedali) e sono esclusi i reparti di Neuropsichiatria infantile (su cui quasi nessuna Regione ha risposto) e gli altri reparti.
In valori assoluti troviamo ai primi posti la Lombardia (con 2.705), il Lazio (1.280) e la Liguria (1.061). Tuttavia, se guardiamo al rapporto tra contenzioni e ricoveri effettuati, la Liguria passa in testa, con il 27,22%. Seguono la Valle d’Aosta (18,7%) e la Lombardia (17,4%).
Il Friuli Venezia Giulia, da anni, ha zero contenzioni, sia nei reparti per adulti sia in quelli per minori. L’Emilia Romagna si è impegnata a ridurre fortemente la pratica e in una decina d’anni ha abbattuto del 10% le contenzioni. Nel 2022 ne registrava un 2% rispetto ai ricoveri effettuati. Nei reparti per minori, oggi, in Emilia Romagna non si lega più.
Il monitoraggio delle contenzioni non viene effettuato in modo sistematico da tutte le Regioni
Secondo i dati del Club SPDC no restraint, il gruppo di reparti psichiatrici ospedalieri impegnati a non legare al letto, nel 2022 su 318 SPDC erano solo 20 quelli che dichiaravano di non applicare mai misure di contenzione meccanica (Caltagirone, Carpi, Castiglione delle Stiviere, Grosseto, Mantova, Melegnano, Merano, Parma, Pescia, Pordenone, Prato, Ravenna, San Bonifacio, San Giovanni in Persiceto, San Severo, Siena, Terni, Trento, Trieste e Udine).
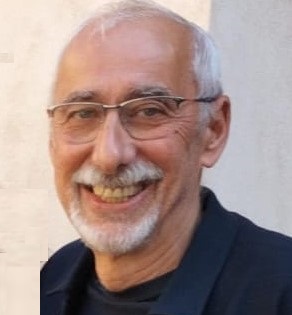
«Non è un caso che si tratti di centri di grandezza media – afferma Giovanni Rossi, già direttore del dipartimento di Salute mentale di Mantova e presidente di Club SPDC no restraint -. Laddove esiste una rete di servizi sociali e territoriali che intercettano le situazioni prima che sfocino in crisi e laddove i servizi di medicina d’urgenza condividono un approccio adatto a persone con problemi psichici o di dipendenza patologica, gli SPDC non sono gli unici a occuparsi della salute mentale delle persone. Senza queste basi tutto si complica».
Situazione frequente è quella di una persona che sia in preda a una crisi e abbia in corpo delle sostanze: prima di essere trasferita in Psichiatria, va eseguito un intervento di disintossicazione «che è meglio effettuare in Pronto Soccorso».
Come funzionano le pratiche no restraint
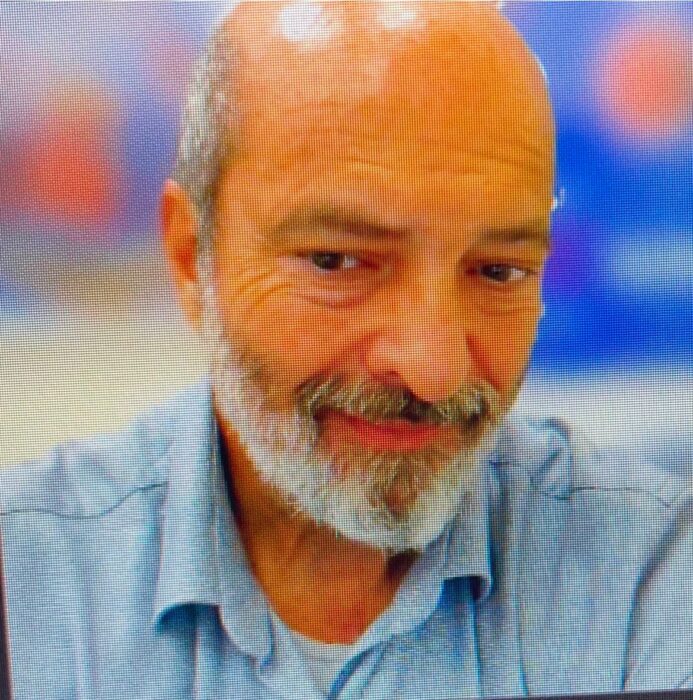
Se, nonostante servizi territoriali e ospedalieri formati, una persona ha una crisi all’interno di un SPDC no restraint che cosa succede? «Intanto si è costruita una relazione con il personale del reparto che è diversa da quella che può esserci tra un paziente e un chirurgo», afferma Roberto Muratori, che per 20 anni ha lavorato nell’SPDC di San Giovanni in Persiceto (dal 2010 come Direttore) e oggi è Direttore dell’Unità complessa di Psichiatria di Bologna Est. «I nostri operatori a San Giovanni, per esempio, mangiavano con gli utenti. Parlo al passato perché purtroppo questo non accade più: per problemi di budget l’ospedale non può pagare i pasti a tre persone in più».
La relazione personale fa sì che si stabilisca un rapporto di fiducia: «Nel caso di una forte crisi, interviene il professionista che si sente più vicino al degente, quello che ha instaurato un rapporto migliore – racconta Muratori -. Se l’aggressività è tale da non riuscire a essere smorzata dalla relazione, si ricorre al blocco fisico: si abbraccia l’utente, impedendogli di arrecare danno a sé o agli altri. In quel modo il medico o l’infermiere suda con chi è in crisi, soffre insieme a lui. Nel frattempo continua a parlargli per far scemare la rabbia».
L’anno scorso è uscito un primo studio, svolto in collaborazione con il CNR, sulle politiche di non contenzione in Italia: si tratta di uno studio descrittivo su scala nazionale composto da 60 domande sugli aspetti strutturali, organizzativi e operativi degli SPDC che non contengono o aspirano a eliminare la contenzione meccanica. «Si tratta del primo tentativo a livello internazionale di documentare in modo scientifico quello che si fa nei reparti no restraint – afferma Rossi, che è tra gli autori del lavoro -. Adesso stiamo per partire con la seconda fase, mirata a trovare gli elementi caratterizzanti la pratica no restraint con l’obiettivo di stabilire un protocollo attuabile ovunque ci sia l’interesse».
«Il problema maggiore è culturale»
A fine 2024, il Collegio nazionale dei direttori dei dipartimenti di salute mentale ha denunciato la carenza di risorse destinate alla salute mentale in Italia: mancherebbero almeno 2 miliardi e servirebbe il 30% di personale in più, pari a circa 7.500 operatori.
Nel 2001 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni aveva confermato all’unanimità di destinare almeno il 5% dei Fondi sanitari regionali per le attività di promozione e tutela della salute mentale. Un obiettivo che oggi appare molto lontano: l’Italia, agli ultimi posti in Europa tra i Paesi ad alto reddito, destina circa la metà, il 2,5%.
«Sicuramente la carenza di operatori negli SPDC è un problema, ma non bisogna dimenticare la formazione: quando sono arrivato a Mantova si legava. Dopo non più, e questo a parità di operatori. Certamente se si scende sotto una certa soglia, soprattutto nei servizi territoriali, la carenza diventa un problema», ammette Rossi.
Il nodo più grande, secondo lo psichiatra, è culturale e ha a che fare con il controllo. «I 60 milioni stanziati dal Ministro Speranza erano legati proprio al superamento dei temi della custodia e del controllo. Tre erano gli obiettivi: il primo a scelta delle Regioni, il secondo riguardava il superamento delle contenzioni e il terzo la costruzione di progetti personalizzati che consentissero l’uscita dalle REMS».
Il nodo più grande è quello culturale, riguarda la mentalità
Le REMS sono le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture che accolgono persone autrici di un reato che per problemi di salute mentale sono state ritenute non imputabili ma socialmente pericolose.
«A San Giovanni in Persiceto ogni mattina c’è un gruppo di un’ora in cui utenti, infermieri e medici discutono su come affrontare la giornata – interviene Muratori -. Ho provato a introdurre questa pratica a Bologna, ma ho incontrato forti resistenze da parte di alcune professioni, che non volevano fare un gruppo con i degenti».
C’è poi un tema di idoneità degli spazi: non tutti gli SPDC sono adeguati al tipo di utenza che dovrebbero accogliere. «L’ambiente deve essere accogliente e strutturato per occuparsi di persone con problemi psichici e non sempre questa è una priorità degli architetti che se ne occupano», rileva Rossi.
Legare una persona è un reato?
Il 7 novembre 2024 la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per il caso di un uomo sottoposto a contenzione meccanica in un reparto psichiatrico.
La vicenda è nota come Lavorgna c. Italia (ricorso n. 8436/21) e riguarda un cittadino italiano diciannovenne all’epoca dei fatti al quale, in seguito a alcuni episodi di aggressività nei confronti dei genitori e del personale sanitario, sono state applicate per quasi otto giorni misure contenitive giudicate illegittime.
L’articolo 3 della Convenzione dice che nessuno può essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti. Secondo la Corte Europea, che ha votato all’unanimità, non è stato dimostrato in modo chiaro come il mantenimento della misura restrittiva per quasi otto giorni – un periodo straordinariamente lungo – fosse strettamente necessario e rispettasse la dignità umana del degente.
Mentre il Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è normato dalla legge, la contenzione non è considerata un atto terapeutico. Per legittimarla si fa riferimento al Codice penale laddove si parla di stato di necessità: non è perseguibile chi priva fisicamente un’altra persona della propria libertà se questa persona può commettere atti di autolesionismo o essere pericolosa per gli altri. Legare una persona è un reato? «Non esiste una risposta ben chiara a questa domanda – afferma Rossi -. Chi decide che cos’è lo stato di necessità? Parliamo di una pratica che non esiste solo negli SPDC, ma anche nelle RSA».
E se non si può fare altrimenti?
Il 6 febbraio Giovanni Rossi sarà audito dalla Commissione Diritti Umani del Senato sulle politiche no restraint. «Se potrò avanzare una richiesta, questa sarà l’introduzione del monitoraggio – dice -. Per esperienza so che basta osservare il fenomeno per arrivare a una riduzione delle contenzioni. Certo, servirebbe anche un organismo di controllo terzo che possa intervenire per vedere come viene fatta la contenzione. Credo che la Rete dei Garanti delle persone private della libertà sia adatta: si tratta di figure neutre che potrebbero essere informate in tempo reale sulle contenzioni e con il diritto di ingresso nei reparti. In questo modo potrebbero effettuare la verifica mentre la contenzione è in atto».
La contenzione è un’esperienza traumatica per il degente, ma anche per l’operatore sanitario
Posto che esistono reparti dove da anni il numero di contenzioni è pari a zero, lo psichiatra ammette che ci possano essere delle eccezioni, casi in cui la contenzione sembra l’unica soluzione possibile: «Non escludo che possano delinearsi situazioni estreme dove il personale si senta sopraffatto, ma credo sia importante creare una situazione di monitoraggi e controlli indipendenti che renda tutti più sicuri del fatto che quello che si sta facendo non ha davvero alternative».
E Muratori osserva che «qualsiasi cosa, anche una contenzione, può essere fatta in modo più o meno attento alle esigenze dell’utenza. La contenzione è un’esperienza traumatica per il degente, ma anche per l’operatore sanitario che la mette in pratica. Farlo nel modo più “umano” possibile dovrebbe essere la base».
«Azzerare le contenzioni nelle grandi città è più complicato, mentre attuare politiche no restraint in tutti i centri piccoli o medio-grandi è un obiettivo raggiungibile. Partiamo da qui», conclude Rossi.


