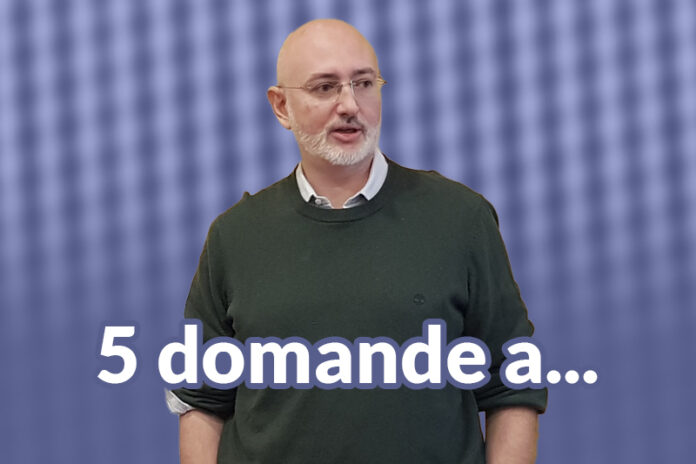Stop alle accuse di “accessi impropri” in Pronto soccorso e all’abuso del termine burnout. Alessandro Riccardi, nuovo presidente SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza), pone l’accento sull’importanza del linguaggio nel dibattito sanitario. Già responsabile della Formazione SIMEU e direttore – da febbraio 2024 – del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Riccardi guiderà la società scientifica nel triennio 2025-27, una fase cruciale per la trasformazione della sanità territoriale. Con l’avvio delle Case di Comunità previsto per giugno 2026, il focus resta sull’evoluzione della medicina d’emergenza-urgenza.
Qual è il ruolo oggi della vostra società scientifica?
«La SIMEU oggi deve fare da garante rispetto al ruolo unico dello specialista dell’emergenza urgenza nell’ambito di un servizio sanitario in trasformazione, con un ospedale che si sta depauperando e in attesa di un territorio che non è ancora potenziato. Al momento attuale il sistema dell’emergenza urgenza è quindi un cuscinetto tra questi due sistemi: uno che si è già ridotto, l’altro che dovrebbe crescere ma è in ritardo. Nella situazione attuale, chi ci rimette è il cittadino, perché quello dello specialista dell’emergenza urgenza è un ruolo veramente fondamentale. Le cooperative hanno creato la falsa illusione che chiunque possa fare il nostro lavoro, ma non è così. Può farlo solo chi è formato. Oggi un Pronto soccorso su due ha in organico almeno un non specialista, chiaramente uno degli obiettivi è avere organici con il 100% di specialisti in medicina di emergenza urgenza, professionisti che sono in grado di riconoscere i sintomi dei pazienti che accedono al Pronto soccorso, di stabilizzare l’urgenza e di lavorare in un continuo multitasking, abituati a gestire molti stimoli in contemporanea. Durante il turno elaboriamo diverse migliaia di informazioni che ci arrivano da più fonti su un singolo paziente, gestendo almeno 10-12 pazienti in contemporanea».
Uno dei dei problemi che state vivendo è la carenza di personale sia strutturale, sia di motivazione. Molti bandi, quando ci sono, vanno deserti o non vengono riempiti tutti i posti a disposizione. Dal suo punto di vista a che cosa è dovuto questo calo di interesse dei futuri medici rispetto alla vostra specialità?
«È dovuto proprio al problema strutturale: un medico che vuole intraprendere questa strada vuole occuparsi dell’emergenza urgenza. Tuttavia, quando entra in ospedale e si rende conto che le carenze del territorio e dell’ospedale ricadono soprattutto sul Pronto soccorso, con il tempo decide di fare qualcos’altro, perché quello non è il lavoro che ha scelto.
Per motivare i giovani medici bisogna migliorare la qualità lavorativa e intervenire sulle retribuzioni
A questo proposito noi parliamo di moral injury: i professionisti, nel caso del boarding per esempio, si ritrovano a svolgere un altro lavoro oltre al proprio, oltre ad assistere a scene di perdita della dignità della persona. Non è uno scenario sostenibile. Sicuramente un requisito fondamentale affinché questa specializzazione torni ad essere attrattiva è migliorare la qualità lavorativa e quella del luogo di lavoro, garantire che gli specialisti facciano il loro lavoro e siano rispettati come tali. In secondo luogo occorre potenziare la parte economica, perché stiamo parlando di un lavoro unico per quanto riguarda l’impegno, lo stress e le rinunce che comporta a causa della turnazione costante, del grande numero di festivi e di notti che richiede. Tutto questo rende difficile interagire con il “mondo civile” e complica la gestione famigliare».
Negli ultimi anni si è fatto un massiccio ricorso alle cooperative di gettonisti: in ospedale sono quindi arrivate persone tendenzialmente meno preparate che percepiscono una retribuzione più alta rispetto agli specialisti assunti. Tuttavia, sono in molti a sostenere che in questo momento questi professionisti siano essenziali per garantire i servizi. Qual è la sua posizione in merito?
«Purtroppo i decisori non hanno recepito negli anni i nostri allarmi sulla carenza di personale perché c’erano dei problemi di spesa. Noi siamo stufi di dover rincorrere l’emergenza e trovare delle soluzioni tampone che poi peggiorano il sistema stesso. Vorremmo che le nostre istanze fossero recepite quando le solleviamo perché annunciano una situazione reale e che potrà evolvere in senso peggiorativo. Quello del personale è un esempio eclatante: quando abbiamo detto che in emergenza urgenza sarebbero mancati diverse migliaia di medici non siamo stati ascoltati. Quando poi questa carenza si è manifestata, ecco che si è cercato di mettere delle toppe per evitare che i servizi chiudessero. Al momento attuale il ricorso ai gettonisti è un male necessario: ribadisco che per superare questo problema occorre intervenire su retribuzione e qualità di vita del personale assunto. Si tratta di rivendicazioni sindacali e non scientifiche, ma se non si farà questo i professionisti continueranno a non arrivare e il Pronto soccorso diventerà un luogo non specialistico dove il personale si limiterà a coprire il turno, senza offrire un servizio di qualità, come sta già accadendo in certe realtà che fanno ricorso a gettonisti esterni».
Un altro tema forte riguarda il sovraffollamento dei Pronto soccorso, spesso a causa di quelli che sono chiamati accessi impropri. A che cosa è dovuto?
«Spesso si sente parlare di accessi impropri al Pronto soccorso, ma SIMEU non ama questa terminologia. Sono senz’altro accessi non appropriati dal punto di vista dell’emergenza urgenza, ma se andiamo a vedere le motivazioni che hanno spinto il cittadino a raggiungere il Pronto soccorso, queste sono assolutamente appropriate perché sono conseguenza di una carenza del territorio. Quindi dare una colpa dell’affollamento agli accessi impropri significa colpevolizzare in qualche modo il cittadino e questo a noi non piace. Ovviamente sarà un’area su cui si dovrà intervenire, grazie al potenziamento del territorio e all’alfabetizzazione del cittadino, ma al momento questo aspetto lo possiamo gestire. In realtà oggi il Pronto soccorso è affollato perché c’è un blocco nell’uscita dei malati: dopo che il paziente è stato stabilizzato rimane in barella in Pronto soccorso, attendendo il suo posto in reparto. È il fenomeno del cosiddetto boarding, causato dalla riduzione dell’assistenza ospedaliera nel corso degli anni.
Dare la colpa dell’affollamento del Pronto soccorso agli accessi impropri significa colpevolizzare il cittadino
Il Ministero configura il boarding se il paziente attende in barella per oltre 8 ore. In Italia i dati dell’anno scorso dicono che i pazienti aspettano un posto letto per una media di 31 ore, una cifra da medicina di guerra e non da paese civile. Si tratta di un dato inaccettabile e di un’assistenza non di qualità, perché il paziente che staziona in corridoio non ha privacy, non ha la possibilità di essere assistito dai familiari, è in un luogo rumoroso e sempre illuminato. Nonostante i nostri sforzi, il livello di assistenza che possiamo garantire a queste persone non è comparabile con quello di un reparto, ma allo stesso tempo, seppur inadeguato, sottrae tempo ed energie al nostro mandato principale, peggiorando la qualità complessiva del sistema. Il boarding non è l’unico problema e non è costante, ma interessa il 90% degli ospedali italiani».
In medicina e non solo si parla molto di intelligenza artificiale. La utilizzate nel vostro lavoro quotidiano? E come funziona dal suo punto di vista la formazione?
«In questo momento di forte carenza di personale ciò di cui abbiamo bisogno è l’intelligenza umana, più che quella artificiale, che sicuramente ci può essere molto di aiuto. Purtroppo dobbiamo risolvere una serie di problemi a monte, prima di arrivare a utilizzare queste tecnologie: l’estrema regionalizzazione dei servizi fa sì che ogni ASL, a volte ogni ospedale, abbia un sistema operativo autonomo che non è in grado di comunicare con gli altri e spesso le strutture informative sono arcaiche perché mancano gli investimenti. Questo si traduce in ospedali della stessa città che non riescono a comunicare gli uni con gli altri o mandare immagini da un consulente all’altro perché ci sono problemi di interfaccia informatica, abbiamo degli ospedali che non riescono a creare delle cartelle condivise tra sedi diverse. Esiste un grosso problema di alfabetizzazione informatica dal punto di vista delle strutture. Anche l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico non è uniforme: alcune realtà possono vederlo, altre no. Dovremo arrivare a un sistema universalistico anche dal punto di vista informatico, in modo da avere un flusso di dati che sarà utile anche per la ricerca perché il sistema di raccolta e di comunicazione è veramente arcaico.
Esiste un grosso problema di alfabetizzazione informatica dal punto di vista delle strutture, con sistemi che non si parlano e l’impossibilità di creare cartelle condivise tra sedi diverse
Solo a questo punto potremo e dovremo ragionare di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la formazione, sicuramente l’università sta facendo dei passi importanti: la specialità dell’emergenza urgenza è una delle ultime arrivate e abbiamo avuto qualche problema di partenza. La situazione degli atenei è abbastanza disomogenea, ma ci sono delle ottime realtà che hanno compreso che il Pronto soccorso si impara in gran parte sul campo e che quindi garantiscono la circolazione degli specializzandi, mentre ci sono altre realtà che sono ancora un po’ indietro. Per questo abbiamo bisogno che siano garantiti livelli di competenza base che gli specializzandi dovrebbero avere per poter intraprendere questo lavoro».