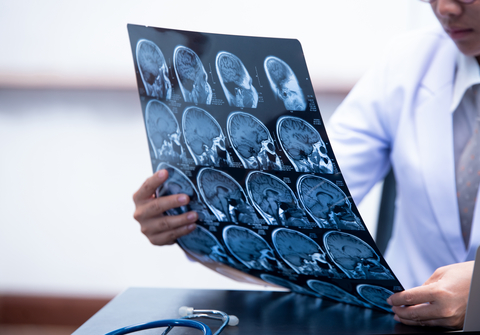Se il proverbio dice il vero, e la lentezza è davvero una ricchezza, questo principio è stato ben compreso dai fondatori di Slow Medicine. Ma la lentezza, intesa come pigrizia o svogliatezza, qui non c’entra. Slow Medicine è un movimento che promuove un approccio all’assistenza sanitaria centrato su cure appropriate, personalizzate e di qualità, evitando sprechi e contenendo i costi per il SSN. È una medicina riflessiva e misurata, che valorizza il tempo necessario per comprendere e rispondere ai bisogni del paziente. L’obiettivo non è solo curare, ma farlo nel modo giusto, coinvolgendo attivamente il paziente nelle decisioni terapeutiche, per garantire una cura consapevole e partecipata. Ma tutto questo come si integra con le nuove tecnologie digitali che nascono, invece, per velocizzare gli interventi?
Rispondono a TrendSanità Marco Bobbio (presidente Slow Medicine), Nicola Draoli (consigliere nazionale FNOPI) e Gianluca Giaconia (vicepresidente AIIC).
Diagnosi e responsabilità medica
«Le tecnologie non sono né buone né cattive – ci dice Bobbio. Dipende da come sono utilizzate, da come scegliamo di applicarle. Possono migliorare il rapporto con il paziente, ma possono anche avere l’effetto opposto. È difficile prevedere quale sarà il loro utilizzo predominante, ma la mia impressione è che si rischi di rendere il rapporto medico-paziente più anonimo. Non solo, possono anche condizionare il giudizio del clinico. Immaginiamo una situazione in cui il paziente descrive i suoi sintomi e il medico formula una diagnosi, ma poi consulta un sistema di intelligenza artificiale. Che succede se l’algoritmo propone una diagnosi diversa?
Fare una diagnosi significa assumersi una responsabilità, anche a livello legale

Se poi ci fosse una contestazione e la diagnosi del medico risultasse sbagliata, la presenza di una diagnosi formulata dall’algoritmo, ben precisa e non accettata, potrebbe renderlo colpevole di non aver seguito il suggerimento dell’AI. Al contrario, se accetta la diagnosi dell’algoritmo, rischia di perdere la sua autonomia professionale. In questo modo, diventa inutile che il medico formuli le sue ipotesi, poiché dipenderà comunque dall’algoritmo. Fare una diagnosi significa assumersi una responsabilità. È un tema discusso anche in ambito giuridico: se la diagnosi formulata dall’algoritmo fosse errata, di chi sarebbe la colpa? Del medico che l’ha approvata, di chi ha acquistato la tecnologia, dell’ospedale, della ditta che l’ha commercializzata o dell’ingegnere che ha sviluppato il software? Questa domanda rappresenterà una questione importante in futuro, un tema complesso che richiede una riflessione approfondita su come integrare correttamente la tecnologia».
Integrazione è la parola chiave
Possiamo chiederci quindi se esistono tecnologie che possono essere utilizzate in modo coerente con l’approccio della Slow Medicine. «La risposta non è semplice – afferma Giaconia, vicepresidente AIIC – anche perché la nostra esperienza come ingegneri clinici ci porta a ragionare sempre in termini di evidenze. Siamo abituati a valutare le tecnologie in ottica HTA (Health Technology Assessment), quindi abbiamo bisogno di evidenze concrete che dimostrino l’efficacia di una tecnologia. Ma, premesso questo, è evidente che alcuni approcci potrebbero dover essere rivisti, soprattutto nel mondo della salute. Una delle principali aree di criticità è il livello di assistenza dei medici di medicina generale. Oggi, il medico di base spesso è ridotto a un ruolo di semplice prescrittore e rischia di perdere la visione d’insieme del paziente. L’uso della telemedicina potrebbe essere un primo passo per ristabilire un rapporto più diretto e umano con il paziente, riducendo la necessità di visite “in presenza” per attività semplici come l’aggiustamento di una terapia. Tale approccio consentirebbe di dedicare più tempo alla cura personalizzata, aumentando l’efficienza senza compromettere la qualità del rapporto umano».
La rivoluzione digitale deve riguardare le persone, non solo la tecnologia

Interviene Draoli: «La prima domanda che emerge è se l’uso crescente delle tecnologie rischia di disumanizzare la cura o se, al contrario, può migliorare la qualità delle terapie e dell’informazione al paziente. Gli infermieri si interrogano da tempo su questo. L’utilizzo di strumenti come il telemonitoraggio, la teleassistenza e il controllo remoto dei parametri vitali, permette di migliorare l’efficacia della presa in carico degli assistiti, specialmente sul territorio, e gestire i consulti a distanza, non solo tra medici ma anche tra tutte le professioni sanitarie, favorendo la collaborazione interprofessionale. Il rischio di disumanizzazione esiste, ma non è tanto una questione tecnologica quanto di come la tecnologia si inserisce nella cura. La rivoluzione digitale riguarda le persone, non solo la tecnologia».
Nuove tecnologie e automatizzazione: più tempo e più attenzione al paziente?
Non è detto che le nuove tecnologie consentano di far guadagnare tempo, con il risvolto positivo di poter dedicare maggiore attenzione al paziente. « Il problema dell’attenzione al paziente non riguarda solo il tempo – interviene il presidente Slow Medicine. Spesso si sente dire, anche dai medici, che abbiamo solo dieci minuti per valutare un paziente e quindi è difficile dedicare abbastanza tempo. In parte è vero, ma non è solo una questione di quantità di tempo, dipende anche da come si usa quel tempo. I nuovi strumenti diagnostici potrebbero, però, essere orientati e progettati affinché anche il parere del paziente diventi parte integrante del processo decisionale. Tuttavia, se dovessi fare una previsione, direi che gran parte dello sviluppo di queste tecnologie mira ad accelerare i processi, rendendo tutto più efficiente, ma non necessariamente più efficace o più umano. Il rischio è che la medicina diventi sempre più distante dai pazienti e questo mi preoccupa».

«L’uso della tecnologia in ospedale – ci dice Giaconia –, è spesso indirizzato a soluzioni molto avanzate, come la chirurgia robotica o le grandi apparecchiature di diagnostica per immagini. Un clinico che utilizza queste tecnologie può mantenere una visione globale del paziente o rischia di concentrarsi esclusivamente sulla singola lesione da trattare? La risposta non è semplice, ma il rischio di trasformare un intervento chirurgico o un referto diagnostico in un processo meccanico, piuttosto che umano, è reale. L’appropriatezza non significa solo precisione tecnologica, ma anche avere il tempo giusto per ogni passo del percorso di cura. Un altro elemento critico è la gestione del tempo. Gli operatori sanitari lamentano costantemente la mancanza di tempo. La tecnologia, in teoria, dovrebbe poter ridurre questa pressione, ma spesso la sua implementazione non è efficace.
Se una vera relazione umana mancava già prima della digitalizzazione, la tecnologia rischia di amplificare questo problema. Al contrario, se la tecnologia è utilizzata all’interno di un contesto relazionale ben strutturato, può potenziare la prossimità e la cura del paziente
In pratica, l’AI potrebbe ridurre il carico di lavoro dei medici, supportando la diagnosi e l’aggiustamento delle terapie, diventare uno strumento di supporto che permette al medico di lavorare con meno stress e più sicurezza. La tecnologia, però, non è di per sé la soluzione ai problemi di gestione del tempo e qualità delle cure. Deve essere inserita in un modello organizzativo funzionale. Se integrata in un contesto in cui il rapporto col paziente è già debole, rischia di peggiorare la situazione. Al contrario, in un approccio relazionale forte, la tecnologia può diventare un fattore facilitante e un moltiplicatore di valore».
La ricerca che manca
Uno dei problemi principali degli strumenti diagnostici automatici è che spesso si crede siano più accurati dei medici, ma questo è il cosiddetto bias del risultato positivo: sono pubblicati quasi esclusivamente i risultati positivi. «Se un sistema di intelligenza artificiale per la diagnosi risulta peggiore dei medici, quei risultati non sono pubblicati – spiega Bobbio. Ciò crea un’impressione distorta: sembra che tutti questi sistemi funzionino meglio dei medici, perché vediamo solo gli studi in cui ottengono risultati superiori. La domanda vera è: queste “migliori” diagnosi miglioreranno davvero la vita dei pazienti? Li faranno vivere più a lungo o meglio? Finora non si è quasi mai confrontato l’impatto concreto di questi sistemi, ovvero se, dopo anni, i pazienti trattati con diagnosi automatiche stanno meglio di quelli seguiti da medici umani. Dovremmo fare studi simili a quelli sui farmaci, che dimostrino non solo un miglioramento nei parametri, ma anche un impatto sulla salute, come la riduzione di infarti o della mortalità. Ad oggi, però, studi di questo tipo su larga scala mancano.
Quello che manca oggi è verificare se questi strumenti, oltre ad essere più accurati, migliorano davvero la qualità della vita dei pazienti
Ci sono sistemi di analisi delle immagini che riescono a leggere le radiografie meglio dei radiologi, ma cosa significa “meglio”? Significa che rilevano elementi che avrebbero danneggiato il paziente se non individuati, o solo dettagli irrilevanti che generano ansia inutile? Immaginiamo di avere uno strumento molto preciso per analizzare il flusso sanguigno nel cuore. Scoprirebbe che quasi tutti hanno una lieve insufficienza mitralica, una condizione normale e clinicamente irrilevante. Ma se tutti i pazienti fossero informati di questa “anormalità”, potrebbero entrare in ansia e avviare periodicamente controlli superflui».
Territorialità e vulnerabilità digitale
«La vera rivoluzione digitale dovrebbe partire dal territorio – conclude Draoli – dove la tecnologia può accorciare le distanze e supportare la medicina territoriale, spesso in difficoltà rispetto agli ospedali. L’assistenza sul territorio può beneficiare della telemedicina e del monitoraggio remoto, consentendo una presa in carico continua dei pazienti anche fuori dall’ospedale. In quest’ottica, l’infermieristica territoriale, come quella degli infermieri di famiglia e comunità, può consentire la costruzione di relazioni durature con i pazienti e la conoscenza dei bisogni della collettività. C’è poi la “fragilità digitale” dei pazienti, specialmente gli anziani o chi vive in aree con scarsa connettività, che hanno difficoltà nell’usare le tecnologie, che da vantaggio potrebbero diventare un ostacolo. La rivoluzione digitale, quindi, non deve essere l’obiettivo, lo è la cura delle persone. Bisogna capire come le tecnologie possano aiutare. Prima di implementare modelli digitali, occorre definire il modello organizzativo e l’approccio alla cura delle persone. Solo così la tecnologia diventa uno strumento funzionale, non un fine».