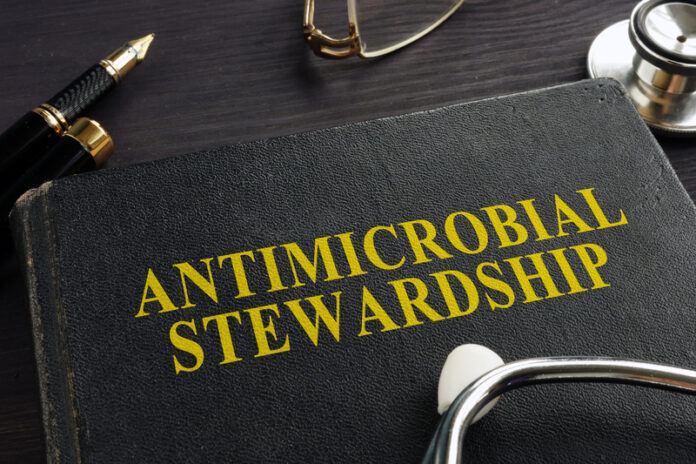L’antimicrobico-resistenza rappresenta una delle più gravi minacce per la salute pubblica a livello globale, ma anche un’occasione concreta per ripensare in chiave sistemica il funzionamento del nostro Servizio Sanitario.
Secondo una definizione del 2017, l’Antimicrobial Stewardship (AMS) è “un coerente insieme di azioni che porti ad utilizzare gli antimicrobici in maniera da assicurare un accesso sostenibile alle terapie efficaci per tutti coloro che ne abbiano bisogno”.
Con il progetto ARCO (Approcci di Rete per il Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza Ospedale-Territorio), nato nel 2023 in Veneto, si è avviato un percorso per fotografare lo stato di attuazione delle politiche regionali in tema di antimicrobico-resistenza, facendo emergere buone pratiche, criticità e disomogeneità tra le aziende sanitarie.
La seconda fase del progetto – ARCO Step II – ha poi ampliato il campo d’indagine all’intero Triveneto, includendo anche il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’obiettivo di costruire una visione interregionale condivisa.
Il 16 maggio 2025 si è tenuto a Padova un workshop che ha coinvolto esperti provenienti da diversi ambiti professionali e ha rappresentato un momento chiave di questo percorso, trasformando evidenze e dati in proposte operative concrete. I partecipanti si sono confrontati su alcuni tavoli tematici, lavorando attivamente per definire priorità, criticità e soluzioni. La discussione in ogni tavolo tematico si è basata su predefiniti statement strategici, valutati in base a rilevanza e fattibilità.
La personalizzazione dell’approccio
In apertura del workshop, il dottor Massimo Crapis, attualmente Coordinatore del Progetto Rete Provinciale Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara e già Responsabile del programma di Antimicrobial Stewardship presso la Struttura Semplice di Malattie Infettive dell’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale”, ha presentato in plenaria un caso clinico emblematico.
L’obiettivo era evidenziare come differenti contesti organizzativi possano condurre a scelte terapeutiche differenti, che non sempre risultano ottimali in termini di uso dell’antibiotico. Il dottor Crapis ha infatti mostrato come il medesimo caso possa essere gestito in modo microbiologicamente corretto ma con approcci diversi, per tempistiche e tipologia di trattamento.
Un elemento centrale emerso dalla discussione è che alcune configurazioni organizzative possono favorire un uso subottimale degli antibiotici, aumentando così il rischio di sviluppare l’antibiotico-resistenza.
Nelle sue conclusioni, il dottor Crapis ha sottolineato che non esiste un unico modello di Antimicrobial Stewardship valido ovunque: per questo non è sufficiente redigere un documento per realizzare un programma efficace. Serve convinzione da parte di chi lo promuove e un adattamento concreto alla realtà epidemiologica e organizzativa locale. L’approccio ottimale sarebbe quello costruito su misura a livello di singolo reparto, anche se questo, nella pratica, non è sempre realizzabile.
Governance e organizzazione: dalla strategia alla pratica
Il primo tavolo di lavoro del workshop ha affrontato un tema spesso sottovalutato ma cruciale: la governance della stewardship antimicrobica. È emersa con forza la necessità di dotare le aziende sanitarie di strumenti di governo chiari, integrati e realmente operativi, capaci di trasformare l’AMS da iniziativa clinica ad azione sistemica e misurabile.
I partecipanti al workshop hanno riconosciuto come estremamente rilevanti tutti gli statement, mentre la loro fattibilità è stata diversificata. In particolare, i sistemi digitali e di data governance e la governance aziendale integrata AMS-IPC (Antimicrobial Stewardship-Infection Prevention and Control) sono risultati di difficile attuazione.
Obiettivi AMS nei mandati dei Direttori Generali
L’inserimento degli obiettivi AMS nei mandati dei Direttori Generali è stato riconosciuto come un passaggio imprescindibile per elevare il tema da priorità tecnica a responsabilità strategica. Per orientare realmente il cambiamento organizzativo, è necessario che la stewardship antimicrobica sia parte integrante dei mandati assegnati ai Direttori Generali delle aziende sanitarie. Non si tratta di un’operazione formale, ma di una scelta che incide sul sistema di priorità, sulla distribuzione delle risorse e sulle logiche di responsabilizzazione.
La proposta condivisa dai partecipanti è quella di definire target regionali vincolanti, basati su una fotografia realistica dello stato dell’arte aziendale. La Regione dovrebbe quindi offrire un quadro aggiornato e differenziato, per permettere l’assegnazione di obiettivi calibrati su ciascuna realtà organizzativa, evitando approcci uniformi e irrealistici. Gli obiettivi devono essere non solo misurabili, ma anche dotati di strumenti operativi di accompagnamento: budget, risorse umane, accesso ai dati, e supporto tecnico-scientifico.
Inoltre, è stato fortemente suggerito di collegare questi obiettivi a sistemi premianti, sia in termini di performance economica, sia di valutazione dirigenziale, per garantire un allineamento reale tra intenzioni strategiche e comportamenti organizzativi.
Gli indicatori core per la valutazione
L’inserimento della stewardship nei sistemi di valutazione e accreditamento è considerato il passo successivo e complementare al punto precedente. Un’organizzazione sanitaria può migliorare solo ciò che è in grado di misurare e monitorare. Ecco perché la definizione di un set condiviso di indicatori “core” è stata ritenuta cruciale.
È importante avere indicatori semplici ma clinicamente rilevanti – come il consumo di antibiotici e i dati di resistenza antimicrobica – che siano utilizzati non solo per la rendicontazione, ma anche per orientare decisioni e strategie aziendali. La partecipazione a audit clinici e l’attivazione di processi formativi possono completare il quadro, restituendo un insieme di dati solidi e omogenei.
Nel corso della discussione è emersa infatti l’esigenza di semplificare il sistema di raccolta dati, spesso frammentato tra fonti diverse, e di garantirne l’accesso da parte dei team AMS. Alcuni esperti hanno proposto di includere obbligatoriamente il quesito clinico nelle prescrizioni antibiotiche, come leva per contestualizzare i dati e misurare davvero l’appropriatezza. In parallelo, è emersa la necessità di affiancare al dato numerico strumenti di accountability e investimenti culturali capaci di tradurre i numeri in azioni concrete.
L’importanza dei link professional
La figura del link professional (professionisti che hanno un ruolo di collegamento e leadership per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza all’interno delle strutture) è stata riconosciuta all’unanimità come elemento essenziale per il successo della stewardship, soprattutto nei contesti dove non vi è la presenza continuativa di infettivologi o microbiologi.
Tuttavia, la situazione attuale è tutt’altro che omogenea: in molte realtà queste figure non sono formalizzate, non ricevono formazione specifica né riconoscimento economico o professionale. Alcuni sono designati “di fatto”, senza un mandato operativo né un tempo dedicato.
La proposta del tavolo è stata chiara: serve strutturare il ruolo, definirne le competenze, fornire percorsi formativi accreditati e inserirlo esplicitamente nell’organigramma aziendale. Solo in questo modo si riesce a valorizzare una figura centrale per la buona riuscita dell’AMS, che possa fare da raccordo tra clinici, farmacisti e microbiologi soprattutto nelle realtà prive di un infettivologo.
Interessante la proposta di estendere il modello del link professional anche al territorio, attraverso la creazione di referenti nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e nelle strutture residenziali.
In generale, laddove c’è maggiore difficoltà a trovare professionisti motivati e disponibili (come in ambito chirurgico oppure nelle case di riposo), è ancora più necessario presidiare attivamente la prescrizione antibiotica.
Le criticità della diagnostica microbiologica
Una stewardship priva di un supporto diagnostico tempestivo è un sistema incompleto. Su questo punto vi è stato ampio consenso tra i partecipanti al workshop. È emersa con forza la necessità di potenziare la diagnostica microbiologica – in particolare quella rapida e molecolare – per ridurre il ricorso improprio alla terapia antibiotica empirica e orientare precocemente le decisioni terapeutiche.
Tuttavia, la discussione ha evidenziato criticità diffuse: in molte realtà aziendali, la diagnostica microbiologica non è pienamente accessibile in tutti i contesti assistenziali. Ancora una volta, quindi, il modello organizzativo impatta sull’outcome clinico: in particolare, sono emersi ritardi legati alla mancata copertura diagnostica durante i fine settimana e nelle fasce orarie serali, con conseguenti rallentamenti nelle diagnosi e nelle terapie. A questo si aggiungono ostacoli legati alla scarsa formazione dei prescrittori, ai vincoli economici e regolatori che rallentano l’adozione di nuove tecnologie e al rischio di un uso non selettivo della diagnostica molecolare, che può generare costi elevati e risultati clinicamente poco rilevanti se non correttamente interpretati.
La proposta emersa è quella di sviluppare modelli a rete tra centri hub e spoke, in cui tecnologie e competenze microbiologiche siano condivise e facilmente accessibili. In questa prospettiva, la microbiologia non è più un servizio di supporto ma un partner clinico strategico, da integrare stabilmente nei percorsi decisionali della stewardship antibiotica.
Combattere la frammentazione dei dati
Uno degli ostacoli più ricorrenti nel rendere effettiva la stewardship è la frammentazione dei dati. Senza dati integrati e accessibili, la governance dell’AMS diventa impossibile. Per questo, su questo punto la discussione è stata particolarmente ricca.
Sono state citate esperienze locali di sistemi informativi avanzati – con dashboard, alert clinici, middleware intelligenti – che però restano limitate ad alcune realtà. La maggior parte delle aziende lamenta ancora la mancanza di interoperabilità tra ospedale e territorio, l’assenza di dati microbiologici in tempo reale, e soprattutto l’impossibilità per i team AMS di accedere direttamente ai dati prescrittivi e di consumo per barriere normative e regolatorie legate alla privacy.
Per superare questi ostacoli serve un investimento infrastrutturale e organizzativo, da qui i punteggi bassi per quanto riguarda la fattibilità. Le proposte hanno incluso lo sviluppo di sistemi di Clinical Decision Support System (CDSS), la standardizzazione dei flussi informativi, l’accesso riservato ai team AMS per l’analisi dei dati sensibili e l’integrazione tra sistemi clinici e amministrativi. È stato anche sollevato il tema della governance del dato, oggi spesso priva di una regia aziendale che possa valorizzare le informazioni disponibili ai fini decisionali.
Verso una governance integrata AMS–IPC
Infine, il tavolo ha affrontato una delle criticità più strutturali: la frammentazione della governance aziendale. In molte aziende convivono più comitati e gruppi spesso non coordinati tra loro e con ruoli sovrapposti. Questo genera inefficienze, vuoti di responsabilità e una governance operativa debole.
Su questo aspetto è stato proposto un cambio di paradigma: una governance snella, integrata, con un’unica regia tra AMS e IPC, ospedale e territorio, pubblico e privato. Le Direzioni Mediche e delle Funzioni Territoriali devono assumere un ruolo di coordinamento trasversale, affiancato da team multidisciplinari con mandato operativo, risorse e obiettivi chiari.
È stata proposta la formalizzazione, tramite atti aziendali, della struttura di governance, definendone composizione, funzioni e flussi decisionali. Il modello ideale è quello di una rete clinico-organizzativa in cui i team AMS e IPC collaborano, condividono dati e decisioni, e dialogano con la direzione strategica. In questo modo, la stewardship diventa un’infrastruttura stabile del sistema, e non un progetto temporaneo.
Dalla teoria alla costruzione di una stewardship sistemica
Il lavoro del Tavolo 1 ha messo a fuoco un elemento essenziale: la stewardship antimicrobica non può essere delegata solo alla buona volontà dei clinici o alla sensibilità dei singoli. Serve una governance solida, dotata di strumenti, risorse e responsabilità chiare.
Gli strumenti oggi ci sono – obiettivi nei mandati, indicatori, link professional, diagnostica, data governance – ma serve la volontà organizzativa di metterli a sistema.
Il confronto ha evidenziato l’esistenza di modelli replicabili, ma anche criticità comuni che richiedono un coordinamento sovra-aziendale. Il messaggio emerso è chiaro: l’AMS può diventare una leva potente per migliorare qualità, sicurezza e sostenibilità del sistema sanitario, ma solo se inserita in una cornice di governance integrata e orientata al cambiamento.