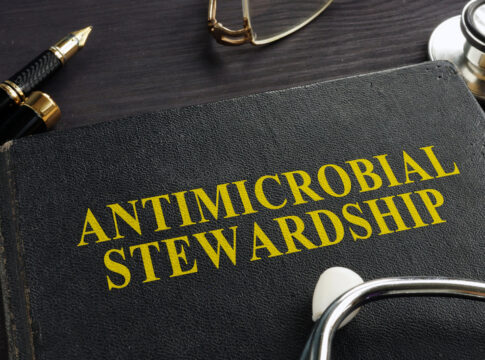Che cosa ostacola l’accesso equo e tempestivo alle cure? Quali sono le disuguaglianze che impattano maggiormente sui cittadini e sui pazienti? Parte da queste domande il secondo Patient Access Journey Monitor promosso dal Patient Access Think Tank con la Senatrice Daniela Sbrollini.
Il report, presentato a Roma nel mese di luglio, intende fornire gli strumenti per promuovere un cambiamento culturale e operativo nella gestione dei bisogni di salute.
Frutto di un lavoro congiunto tra accademici, società scientifiche, istituzioni e associazioni civiche e di pazienti, il Report 2025 – dal titolo Patient Access – From Journey to System – affronta criticità trasversali: dalla cronicità all’innovazione digitale, dalle malattie rare alla salute mentale, dall’equità di genere alle nuove vulnerabilità sociali. Con un approccio operativo, il documento propone modelli predittivi, interventi comportamentali e soluzioni pratiche pronte a essere messe in campo.
Che cos’è il Patient Access
Quando parliamo di Patient Access non intendiamo semplicemente l’accesso del paziente: «Non si tratta solo di un fatto di advocacy giusta per il paziente, ma di una modalità che coinvolge tutto il sistema, dalla governance sanitaria, agli aspetti clinici fino a quelli sociali e imprenditoriali – ha ricordato Federico Serra, Chairman del Patient Access Think Thank promosso da BHave -. Serve un sistema unico attorno all’accesso alle cure, perché tutto ciò che è silos nella sanità significa esclusione».
Il termine fu introdotto dall’Affordable Care Act, la riforma sanitaria voluta dall’allora presidente statunitense Barack Obama: l’implementazione quadriennale del programma includeva tra le altre cose una serie di disposizioni per l’accesso a opzioni di assicurazione accessibili.
Il Patient Access significa infatti garantire a ogni persona, indipendentemente da condizione sociale, genere, luogo di residenza o patologia, la possibilità concreta di accedere, nel momento giusto, alle cure appropriate, superando barriere strutturali, economiche, culturali e comportamentali.
Integrare nel SSN unità comportamentali
Andrea Lenzi, professore emerito di Endocrinologia all’Università La Sapienza, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e neo-presidente del CNR, ha affermato: «Questo Monitor non è solo una raccolta dati: ci sono delle piattaforme strategiche di raccomandazioni operative che sono molto utili a chi le voglia intercettare e applicare. Si tratta di un volume di evidence-based patient access».
Il Patient Access Monitor 2025 propone, tra le altre cose, l’istituzione di unità comportamentali integrate nel sistema sanitario nazionale, per migliorare l’aderenza terapeutica e ottimizzare l’efficacia degli interventi preventivi. Questo tipo di approccio si basa sul riconoscimento che molte decisioni sanitarie sono influenzate da bias cognitivi, barriere procedurali e fattori contestuali che possono essere modificati attraverso interventi mirati. Le unità comportamentali, infatti, sono team multidisciplinari specializzati nell’applicazione delle scienze comportamentali alle politiche pubbliche.
Ripensare i modelli organizzativi
Il potenziamento della sanità territoriale e un’assistenza sempre più decentrata sono tra gli obiettivi del PNRR e del DM77. Tuttavia, spesso questa trasformazione è chiara sulla carta, ma quando deve essere messa in pratica si scontra con una serie di criticità, tra cui l’assenza di dati sui costi evitati e i risparmi (non solo economici) di questo cambio di setting.
«Il sistema sanitario nazionale dovrebbe modificare il paradigma di accesso, alla luce dei cambiamenti che hanno interessato la platea cui si rivolge – ha affermato il senatore Guido Quintino Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne -. La nostra sanità dovrebbe essere più performante e accessibile, in grado di plasmarsi in maniera dinamica a partire dalle suggestioni che arrivano dal territorio».
Tra i casi presi in considerazione nel Patient Monitor 2025 c’è quello delle isteroscopie, una procedura che oggi viene erogata per la maggior parte in ambito ospedaliero. I dati, tuttavia, hanno dimostrato che l’approccio ambulatoriale ridurrebbe fino al 60% i tempi di attesa, abbattendo del 70% i costi diretti. Inoltre, l’approccio “see and treat” che consente diagnosi e trattamento in un’unica seduta eviterebbe oltre la metà dei ricorsi a ulteriori procedure in sala operatoria, oltre a una riduzione delle giornate lavorative perse rispetto all’erogazione della prestazione in ospedale.
«Nella sola Lombardia, che pure è una Regione virtuosa, lo shift di una parte dei trattamenti permetterebbe un risparmio di 58 milioni all’anno», ha affermato Claudia Georgia Banella, Direttrice Generale e Amministratrice Delegata di Karl Storz Endoscopia Italia.
In Lombardia infatti ci sono circa 227.000 isteroscopie ogni anno. Di queste, il 68% avviene in sala operatoria. Il risparmio citato da Georgia Banella riguarda lo spostamento della metà degli interventi da sala operatoria a ambulatorio, che libererebbe ogni anno 116.000 ore di sala operatoria, che potrebbe essere utilizzata per altre patologie. Secondo la letteratura scientifica infatti il 75-80% delle isteroscopie potrebbero essere gestite al di fuori della sala operatoria.
Combattere il ritardo diagnostico
L’accesso alle cure è ancora più problematico quando si parla di una malattia rara, dove i pazienti sono pochi e i medici non vedono spesso i sintomi delle patologie. Il ritardo diagnostico è tra gli ostacoli più rilevanti a un servizio sanitario davvero equo.
Tra gli esempi citati nel Patient Monitor c’è quello dell’esofagite eosinofila (EoE), il cui ritardo diagnostico in Italia ha una mediana di 36 mesi, ma può anche superare i 6 anni.
L’EoE, come molte patologie, è però progressiva e, se non trattata adeguatamente, può portare a complicanze anche serie, come la stenosi esofagea, che aumenta del 9% per ogni anno di ritardo diagnostico, con gravi ripercussioni sulla salute e sulla qualità di vita del paziente.
«Per migliorare l’accesso, occorre innanzitutto lavorare sull’awareness della patologia – afferma Giuseppe Isoni, General Manager Dr. Falk Pharma Italia -. I pazienti vanno aiutati, sia nella fase di diagnosi, nella diffusione della conoscenza sulla malattia, sia dopo, con incontri, diffusione di materiali e l’istituzione di una Giornata dedicata alla patologia, tutti aspetti che supportano il paziente non solo nella gestione farmacologica, ma in quella di una malattia cronica».
La difficoltà nella presa in carico
Le malattie allergiche respiratorie sono in crescita a livello globale: secondo l’OMS, nel mondo ne soffrono 350 milioni di persone. In Italia, interessano circa il 15-20% della popolazione, con un impatto particolarmente significativo sui bambini: il 10% degli under14 soffre di asma e nell’80% dei casi la causa è allergica.
L’onere sociale ed economico è importante: si calcola che i costi diretti rappresentino circa l’1-2% della spesa sanitaria totale, mentre i costi indiretti, come l’assenteismo scolastico e lavorativo, in molti casi superano il 50% dei costi complessivi.
«Nonostante questi dati, ancora oggi una delle problematiche principali legate alle malattie allergiche e respiratorie è la loro banalizzazione: spesso si associa l’allergia a una rinite o a un raffreddore da fieno, mentre spesso nella stessa persona convivono più condizioni patologiche che vanno dall’asma alla rinite allergica, alla dermatite atopica», riporta Sandra Frateiacci, Presidente ALAMA APS e Dipartimento Salute OPES APS; Vicepresidente FederASMA e ALLERGIE Odv.
Anche alla luce di questi dati, è stato elaborato in Italia il Manifesto dei diritti delle persone con allergie respiratorie, che punta i riflettori – tra le altre cose – sulla parità di accesso all’informazione, sulla prevenzione e sull’educazione terapeutica.
«La persona con allergia respiratoria è un testimone della grande disparità che esiste, a livello di sistema sanitario italiano, di esigibilità della terapia – rileva Sabrina De Federicis, Country Manager HAL Allergy -. Soprattutto per quanto riguarda la terapia desensibilizzante, che è l’unica riconosciuta dall’OMS come terapia curativa e non sintomatica, esiste una disparità assoluta poiché questa non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale, ma è a discrezione delle Regioni. La Lombardia per esempio da sempre la rimborsa interamente, il Piemonte lo fa al 50%, mentre in Lazio, Calabria o Sicilia il paziente la paga di tasca sua».
I Centri allergologici, a livello nazionale, sono pochi e «quando i medici vanno in pensione, spesso gli ambulatori vengono chiusi – dice Frateiacci -. Le famiglie si ritrovano a inseguire i singoli specialisti, ricevendo anche indicazioni diverse. C’è quindi anche un problema di riconciliazione terapeutica, ovvero occorre capire che tipo di farmaci sono meglio per la situazione del singolo paziente».
I vuoti normativi
La mancanza di definizione legislativa interessa diversi aspetti nel nostro Paese, tra cui quello della nutraceutica. «Da un lato il comparto è in forte crescita, con molti investimenti in ricerca e sviluppo, dall’altro manca di un riconoscimento normativo specifico e questi prodotti sono relegati nella categoria generica degli integratori alimentari, a cui tuttavia possono essere riconosciute solo proprietà nutritive o fisiologiche, non terapeutiche – spiega Valeria Curti, R&D, Medical, Quality and Regulatory Manager Kolinpharma -. L’Italia è leader per quanto riguarda la ricerca e ha una tradizione importante di consumo e di utilizzo. Per questo potrebbe accompagnare l’Europa nella costruzione di una legislazione comunitaria che coinvolga istituzioni pubbliche, mondo accademico e professionisti del settore».