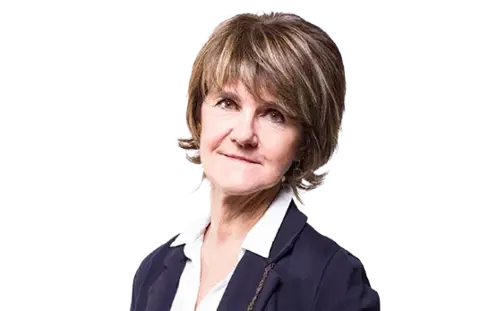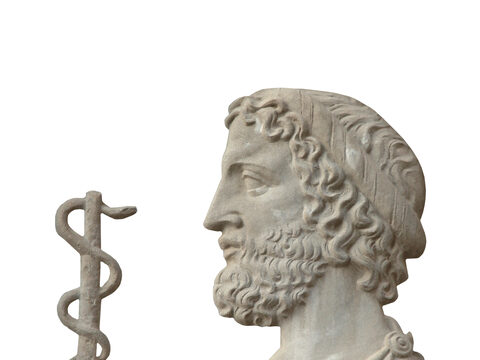Nell’antico Egitto, nel 2000 a.C. già esistevano figure che potevano definirsi donne medico, specializzate in ginecologia. Si parlava di “medicus” per l’uomo e di “medica” per la donna che esercitava la medicina anche nei secoli a venire, in Grecia e nel periodo romano. E a Salerno, intorno al IX secolo, mentre l’Europa dell’alto medioevo stava appena uscendo dal periodo di invasioni barbariche, nacque la prima Università di Medicina d’Europa, dove per la prima volta nella storia si praticava quella che oggi chiamiamo “medicina di genere”.

Le “mulieres Salernitanae”, ovvero le donne mediche, che come Trotula de Ruggiero, curavano le patologie femminili secoli prima che altrove si riconoscesse alle donne il diritto di studiare medicina. Infatti, l’accettazione delle donne nelle università e nella professione medica, senza alcuna forma di discriminazione, si realizzò unicamente a cavallo tra XIX e XX secolo. Oggi, a 26 anni dalla rinascita della facoltà di medicina salernitana, questa eredità rivive attraverso il lavoro dell’Università Popolare Scuola Medica Salernitana. A TrendSanità Pio Vicinanza, medico pediatra e Rettore dell’Università Popolare Scuola Medica Salernitana ne racconta la storia e la rinascita.
La Scuola Medica Salernitana è considerata la prima università di medicina d’Europa. Quanto è ancora viva oggi la sua eredità scientifica e culturale?
«La Scuola Medica Salernitana ha una storia millenaria straordinaria. Nata intorno al IX secolo d.C., deve la sua nascita alla posizione geografica strategica di Salerno, al centro del Mediterraneo e capitale del Principato. Questa posizione favorì gli scambi interculturali con i Paesi Arabi, del Nord Africa e Orientali. La Scuola nacque grazie all’Abbazia di Montecassino, dove i monaci benedettini trascrivevano antichi trattati di medicina per curare i pellegrini, traducendo testi dal greco, dall’arabo e dal latino. Aveva due caratteristiche rivoluzionarie: il sincretismo culturale, ovvero l’unione di culture latine, greche, arabe ed ebraiche, e soprattutto la presenza di donne medico, le cosiddette “mulieres Salernitanae”».
Sincretismo culturale e presenza di donne medico sono stati gli aspetti più rivoluzionari, per l’epoca, della Scuola Medica Salernitana
Parliamo proprio di questo aspetto: chi erano queste donne medico e quale ruolo svolgevano?
«Le donne medico salernitane rappresentavano un unicum assoluto nel panorama medievale. Nascevano per necessità: nel Medioevo l’uomo non poteva toccare o visitare direttamente una donna, poteva al massimo tastare il polso attraverso un paravento. Queste mediche erano spesso figlie di medici salernitani e si dedicavano alla cura delle patologie femminili, della gravidanza, del puerperio e della pediatria. Tra le più importanti ricordiamo Trotula de Ruggiero, Costanza Calenda e Abella Salernitana. Pensi che per avere nuovamente donne medico dovemmo aspettare l’Ottocento! Loro praticavano già nel XI e nel XII secolo quella che oggi chiamiamo “medicina di genere”».
Che cosa sappiamo di Trotula de Ruggiero dal punto di vista storico?
«Trotula nacque a Salerno intorno al 1000-1100, nel periodo di massimo splendore della scuola. Era figlia di Ruggiero, importante medico e archiatra salernitano. Cresciuta nell’ambiente medico, divenne esperta nell’uso delle erbe medicinali e creò persino creme per la cura della pelle femminile. Fondò una vera scuola di donne medico e i suoi trattati sono stati tradotti e studiati anche da ricercatori americani contemporanei, come la studiosa Monica Green, che ha dimostrato come Trotula non fosse solo una leggenda, ma una figura storicamente documentata».
Passiamo all’attualità. Quali strumenti educativi state introducendo per restituire dignità storica e scientifica alla Scuola Medica Salernitana?
«La nostra attività è iniziata 26 anni fa, quando a Salerno non esisteva la facoltà di medicina. Il nostro obiettivo era far conoscere questa eredità alle nuove generazioni e sensibilizzare i politici. Ci siamo riusciti: nel 2005 è stata rifondata la facoltà di medicina e nel 2011 abbiamo avuto i primi laureati, esattamente 200 anni dopo la chiusura della Scuola voluta da Gioacchino Murat nel 1811. Attualmente, organizziamo convegni internazionali di storia della medicina, pubblichiamo volumi, offriamo formazione post-universitaria e abbiamo istituito il Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana, conferito a scienziati di fama mondiale come Umberto Veronesi».
Quale visione avete per il futuro?
La Scuola Medica Salernitana ha anticipato temi di oggi come l’integrazione tra salute, ambiente e alimentazione, alla base dell’approccio One Health
«Stiamo lavorando per ottenere il riconoscimento UNESCO della Scuola Medica Salernitana come patrimonio immateriale dell’umanità. Abbiamo raccolto le firme di grandi personalità scientifiche e abbiamo realizzato documentari che stanno ricevendo premi internazionali. Inoltre, stiamo sviluppando un turismo culturale con la ristrutturazione del Giardino della Minerva, dove Matteo Silvatico insegnava fitoterapia, e il Museo Papi con strumentazioni mediche dal 1400 ad oggi. Portiamo avanti cooperazioni internazionali con i popoli arabi e greci, proprio come faceva l’antica scuola, perché crediamo che la cooperazione tra popoli sia fondamentale per il progresso della medicina».
Per concludere, quale valore concreto può avere oggi l’eredità della Scuola Medica Salernitana per chi opera nella sanità e nella ricerca?
«La storia della medicina è fondamentale per la cultura medica moderna. Quello che i nostri predecessori avevano scoperto empiricamente, oggi la scienza farmacologica lo conferma. La Scuola Medica Salernitana non era solo tecnica medica, ma una filosofia di vita che comprendeva la cura dell’ambiente, dell’alimentazione, anche anticipando la dieta mediterranea, oltre il benessere globale, ovvero, quello che oggi va sotto la definizione di One Health. È un patrimonio che dobbiamo preservare e valorizzare per le future generazioni».