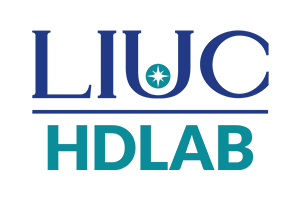Introduzione
Negli ultimi anni, si è registrata una crescente attenzione verso la necessità di modernizzare e trasformare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Un punto di svolta cruciale è stato il 2020, quando la pandemia da SARS-CoV-2 ha reso imprescindibili il distanziamento sociale e la riduzione del contatto fisico, accelerando a livello globale l’adozione di soluzioni digitali e sistemi virtuali.
In questo scenario, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito nel più ampio programma europeo Next Generation EU, ha destinato ingenti risorse al rafforzamento dei sistemi sanitari, delineando una vera e propria svolta epocale verso la costruzione di servizi più resilienti, equi e sostenibili. Tra le tecnologie digitali più promettenti ha assunto un ruolo sempre più centrale la telemedicina. Nata negli anni Sessanta con i primi sistemi di monitoraggio degli astronauti sviluppati dalla NASA, la telemedicina ha conosciuto una significativa evoluzione grazie alla diffusione di internet e dei dispositivi mobili. Oggi rappresenta uno strumento strategico per la gestione a distanza dei pazienti, consentendo il monitoraggio dei parametri vitali (PV) e degli esiti riferiti dai pazienti (PROMs), migliorando l’accessibilità alle cure e contribuendo alla riduzione dei costi complessivi del sistema sanitario.
La telemedicina consente il monitoraggio dei parametri vitali e degli esiti riferiti dai pazienti
Tra i diversi ambiti applicativi della telemedicina, standardizzati a partire dall’Accordo Stato-Regioni del 2014 – attraverso il quale è entrata ufficialmente a far parte dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) – merita particolare attenzione il telemonitoraggio. Questo consiste nel monitoraggio a distanza di parametri clinici mediante l’uso di dispositivi digitali, configurandosi come una risposta innovativa e concreta ad alcune delle principali sfide che oggi interessano i sistemi sanitari.
In un contesto caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione [ISTAT, 2023], da persistenti disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure, e dalla necessità di gestire in modo efficiente patologie croniche e ad alta complessità, il telemonitoraggio si propone come uno strumento capace di migliorare l’equità e l’efficacia dell’assistenza.
Un ambito di applicazione rilevante per quanto concerne il telemonitoraggio riguarda le patologie oncologiche, per le quali, secondo le stime AIRC [I numeri del cancro 2024], si registrano circa 390.000 nuove diagnosi di neoplasie solide ogni anno solo in Italia. Difatti, in tali contesti, il telemonitoraggio può supportare un’assistenza più personalizzata, continua e territoriale, contribuendo a ridurre il carico ospedaliero e a migliorare la qualità di vita dei pazienti, rappresentando pertanto un supporto un supporto fondamentale per i pazienti che risiedono lontano dai centri ospedalieri, consentendo loro di accedere a consulenze specialistiche e servizi di monitoraggio continuo senza dover affrontare spostamenti frequenti e spesso onerosi [AIOM, 2020].
Il telemonitoraggio può ridurre il carico ospedaliero e migliorare la qualità di vita dei pazienti
I notevoli progressi registrati negli ultimi decenni nelle terapie antitumorali e nella gestione clinica delle patologie oncologiche hanno reso possibile la somministrazione di cure attive – ovvero in fasi della malattia in cui i trattamenti antineoplastici sono ancora in corso – anche al di fuori del contesto ospedaliero. In questo scenario si inserisce lo sviluppo dell’assistenza domiciliare oncologica, avviata in Italia già nel 1987 con il progetto pilota DOM, realizzato a Modena, e successivamente estesa ad altre realtà, tra cui l’ASST-Settelaghi che, a metà degli anni ’90, ha avviato il progetto Homcology. Tali iniziative hanno tracciato un percorso di integrazione tra cure domiciliari e ospedaliere, promuovendo un modello di assistenza più vicino ai bisogni del paziente, capace di coniugare efficacia clinica, sostenibilità organizzativa e qualità della vita.
Il modello di assistenza domiciliare oncologica, come quello implementato nel progetto Homcology, si basa su criteri di eleggibilità ben definiti, volti a identificare pazienti che possono trarre beneficio da un percorso di cura attivo al di fuori dell’ambiente ospedaliero. In particolare, possono accedere al servizio:
- pazienti con indicazione a trattamento oncologico attivo ma impossibilitati a recarsi in ambulatorio a causa di disabilità legate alla patologia tumorale o a deficit neurologici e motori non riconducibili direttamente alla neoplasia;
- persone malate che vivono in condizioni ambientali disagiate e/o che presentano difficoltà familiari o sociali tali da compromettere l’accesso continuativo alle cure ambulatoriali;
- pazienti che hanno interrotto le cure attive per la patologia oncologica, in condizioni di fragilità clinica e con una previsione di vita superiore a sei mesi, ma che non soddisfano i criteri per l’inserimento nei programmi di Ospedalizzazione Domiciliare per Cure Palliative (ODCP).
La selezione dei pazienti si articola su due dimensioni principali: l’eleggibilità clinica e le preferenze espresse dal paziente e dal caregiver.
Per quanto riguarda l’eleggibilità clinica, vengono presi in esame diversi fattori, tra cui il tipo di neoplasia, l’indicazione terapeutica, lo stadio e la severità della malattia, nonché le condizioni generali del paziente, valutate tramite strumenti validati come il G8 Screening Tool. Quest’ultimo consente di identificare tre elementi fondamentali per l’accesso al programma: il livello di intensità di cura richiesto, le condizioni socioeconomiche e ambientali, e il grado di alfabetizzazione sanitaria del paziente e del caregiver.
L’assistenza domiciliare in questo contesto si configura non solo come una risposta clinicamente efficace, ma anche come un’opportunità per migliorare il benessere complessivo della persona. Essa consente di ridurre il senso di abbandono, rafforzare la continuità della cura, migliorare l’accessibilità ai trattamenti e abbattere le barriere territoriali. Sul piano organizzativo, si traduce in una gestione più fluida da parte della struttura ospedaliera, con una riduzione dell’affluenza ambulatoriale e un impatto positivo sui costi.
Alla luce di queste premesse, l’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare l’efficacia del telemonitoraggio nell’ambito del progetto, confrontandone gli esiti con quelli derivanti dalla gestione tradizionale in regime di Day Hospital (DH), utilizzando dati real-life. Tale confronto permetterà di esplorare il valore aggiunto del modello domiciliare supportato dalla telemedicina, sia in termini di esiti clinici che di sostenibilità organizzativa ed economica.
Metodi
Per il raggiungimento dell’obiettivo è stata condotta una valutazione multidimensionale, seguendo le logiche dell’Health Technology Assesment (HTA), che risulta essere una metodologia usata in sanità per indagare non solo l’efficacia clinica, ma anche gli aspetti economici, organizzativi e sociali legati all’uso e implementazione della tecnologia nei processi assistenziali.
Giacché la tecnologia oggetto di indagine è il telemonitoraggio, il modello utilizzato è il “Multicriteria Utility-based Structured Tool for Health Technology Assessment” – MAST [Kidholm et al., 2012] che ha permesso di valutare, in maniera olistica, gli impatti dell’Homcology (Scenario TO BE) rispetto allo usual care (Scenario AS IS). Nello specifico, tra i sette domini proposti dal MAST, l’analisi che verrà presentata nel seguito prenderà in considerazione i seguenti quattro impatti:
- outcome clinici, con particolare attenzione alla sicurezza e all’efficacia di Homcology rispetto allo usual care. Nella presente analisi, tali outcome sono stati reperiti mediante raccolta dati di real-life, grazie al grande contributo dell’Area Sviluppo e Ricerca DAPSS Aziendale. Considerando i pazienti riferibili all’attività del DH Oncologico dell’ASST dei Sette Laghi di Varese. Nello specifico è stata posta particolare attenzione all’occorrenza di ricoveri e di accessi in PS per medesima patologia, così così da poter dimostrare non solo un’efficacia temporale nella gestione prematura delle tossicità ma anche la gestione in toto degli effetti avversi alla terapia:
- sostenibilità economica e organizzativa. Anche per la disamina di questo dominio, sono stati raccolti i dati aziendali riferiti ai pazienti in carico nel corso dell’anno 2023 tutti afferenti al servizio di DH aziendale e i pazienti in carico al progetto domiciliare Homcology. Nello specifico si sono definiti i professionisti sanitari coinvolti in entrambi i percorsi, focalizzando l’attenzione sul tempo speso per ogni attività svolta;
- impatto sociale ed etico, sviluppato sottoponendo un questionario qualitativo ai professionisti sanitari che attualmente prestano la propria attività presso le UO di Oncologia Medica, DH e progetto Homcology, così da raccogliere le percezioni dei professionisti sul valore aggiunto di Homcology in termini di soddisfazione e qualità di vita del paziente.
Risultati
In linea generale nell’anno solare 2023 (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 inclusi), afferiscono ai DH Aziendali 1.124 utenti. Il servizio domiciliare Homcology, nel medesimo tempo di riferimento contempla 184 pazienti.
La Tabella 1 mostra le caratteristiche della popolazione coinvolta, unitamente alla necessità di ospedalizzazione e all’occorrenza di decessi.
| Scenario as is Usual CARE |
Scenario to be homcology |
|
|---|---|---|
|
Pazienti totali in carico |
1.124 |
184 |
|
Età media |
62 (18-90) |
71 anni (38-93) |
|
Durata media presa in carico |
160 giorni |
175 giorni |
|
Terapia attiva |
1.561* |
95% 174 pazienti |
|
Numero medio accessi mensili |
2 medico 3 infermieristico |
1.4 medico 1.8 infermieristico |
|
Ricovero |
45% (31% in PS) |
19% (9% in PS) |
|
Decesso |
41% |
38% |
Tabella 1. Comparazione tra scenario AS IS e Scenario TO BE
*La discrepanza dei due dati (pazienti totali in carico e pazienti in terapia attiva) è la somma tra i nuovi trattamenti con i trattamenti in prosecuzione dell’anno precedente
In questa comparazione dei flussi di pazienti presi in carico nel servizio di DH e nel progetto Homcology nel medesimo periodo temporale (anno 2023), escludendo a monte le terapie attive che necessitano dell’infrastruttura in particolare del servizio UMaCA (Unità Manipolazione Chemioterapici Antiblastici), la stima fatta sulla possibilità di prendere in carico i pazienti oggi afferenti al DH e quindi agganciarli al progetto è del 20-30% circa. Questo permette l’identificazione di una nuova popolazione target, che amplia la qualità dell’assistenza soprattutto in pazienti con necessità di monitoraggio regolare, pensiamo alle tossicità, favorendo migliore compliance e partecipazione al processo di cura. Da un punto di vista di efficacy e safety, il dato più significativo dimostra come il telemonitoraggio domiciliare riduca i ricoveri e gli accessi in PS per medesima patologia, fenomeno legato alla tempestività di gestione degli effetti avversi e alla maggiore aderenza alle cure.
Focalizzando l’attenzione sull’impatto economico-organizzativo correlato all’effort delle risorse umane coinvolte per lo svolgimento delle attività dedicate al management dei pazienti, in prima istanza è opportuno definire il bacino di utenza eleggibili a DH e al progetto Homcology. Con l’implementazione della telemedicina quindi si vedrebbe un aumento del numero di pazienti seguiti al domicilio per un 30% totale, il 16% in più rispetto alla situazione attuale, dalla quale deriva un numero di pazienti totali pari a 392 su tutto il territorio provinciale per la sola patologia oncologica in cure attive.
|
As is |
To be |
|||
|---|---|---|---|---|
|
DH |
1.124 |
86% |
916 |
70% |
|
Telemedicina |
184 |
14% |
392 |
30% |
|
Totale |
1.308 |
100% |
1.308 |
100% |
Tabella 2. La popolazione
Proseguendo nell’analisi considerando anche gli accessi annui per controlli, al netto della terapia infusionale i dati sono pari a 17 per quanto concerne il percorso di DH e 9 per quanto concerne il percorso di telemedicina. Rapportando questi valori al totale dei pazienti presi in carico (N = 1.308), emerge che l’adozione del telemonitoraggio è associata a una riduzione complessiva del numero di accessi pari all’8%.
|
Accessi totali |
As is |
To be |
Scostamento |
% |
|---|---|---|---|---|
|
DH |
19.482,6 |
15.870,4 |
-3.612 |
-19% |
|
Telemedicina |
1.674,4 |
3.570,84 |
1.896 |
113% |
|
21.157 |
19.441 |
-1.716 |
-8% |
Tabella 3. Focus sul numero di accessi
Ogni accesso prevede uno slot di 30 minuti, e richiede l’intervento sia del medico oncologo sia dell’infermiere. Traducendo i 1.716 accessi evitati in termini di tempo risparmiato, si ottiene un totale di 51.475 minuti risparmiati. Valorizzando questo saving organizzativo, si riscontra come il risparmio complessivo in termini di effort professionale sia pari a 54.563,29 euro. Questo dato rappresenta un primo indicatore economico del potenziale vantaggio associato all’adozione del modello di telemonitoraggio rispetto alla gestione tradizionale in DH, contribuendo alla sostenibilità del sistema attraverso una razionalizzazione delle risorse umane.
Ultimo dominio indagato è la percezione dei professionisti: come illustrato nella sezione metodologica, è stato somministrato un questionario qualitativo a 40 professionisti che lavorano nell’area oncologica. Di questi, il 90% ha risposto interamente riducendo il campione a 36 soggetti, aventi una età media 35 anni e una anzianità di servizio di 11 anni.
Tutti i professionisti intervistati hanno dichiarato di non aver ricevuto una formazione adeguata sull’uso delle piattaforme digitali, né di avere esperienze pregresse con strumenti di telemedicina. Questo evidenzia una lacuna significativa nei percorsi formativi aziendali, che risultano scarsi o assenti.
Per quanto concerne l’accesso digitale di pazienti e caregiver, solo il 12% degli operatori ritiene che i pazienti abbiano accesso diretto a una rete internet stabile, mentre il 90% ritiene che i caregiver possano supplire a questa mancanza. Questo suggerisce che, pur in presenza di un digital divide generazionale, il coinvolgimento dei caregiver può rappresentare una leva abilitante per l’accesso alla telemedicina.
In linea generale il 70% si sente a proprio agio nel prendere decisioni cliniche via telemedicina, a patto che vi siano buone condizioni comunicative e ambientali. Tuttavia, il 100% del campione esprime incertezza rispetto alla possibilità che la telemedicina offra un’assistenza equivalente alla visita in presenza, soprattutto per il valore attribuito all’empatia e alla relazione diretta nel primo incontro. L’80% giudica inadeguata l’infrastruttura tecnologica aziendale, pur ritenendo nel 90% dei casi che sia possibile gestire efficacemente i pazienti a distanza.
Tutti i partecipanti percepiscono un risparmio di tempo grazie alla telemedicina (60% molto, 40% abbastanza). L’80% ritiene che favorisca un accesso più rapido alle cure, soprattutto per consulti brevi o follow-up. Il 75% è incerto sulle limitazioni diagnostiche, mentre nessuno ritiene che la telemedicina aumenti il carico di lavoro, anche grazie alla riduzione della burocrazia tramite digitalizzazione dei dati. Inoltre, il 75% ritiene che possa migliorare la qualità dell’assistenza al paziente. Tutti sono favorevoli all’implementazione della telemedicina nel progetto Homcology, considerandola adatta per pazienti domiciliari.
Conclusioni
Per approfondire il valore aggiunto dell’implementazione della telemedicina nel progetto Homcology, è utile ricorrere a una lettura in chiave strategica attraverso l’analisi SWOT, che consente di mettere in luce punti di forza, debolezza, opportunità e minacce associati a questo cambiamento organizzativo.
Tra i principali punti di forza, la telemedicina si distingue per la sua capacità di migliorare l’accessibilità alle cure, riducendo le tempistiche di attesa e aumentando l’efficienza dei servizi sanitari. Il monitoraggio continuo consente una gestione più tempestiva e personalizzata dei pazienti, favorendo una maggiore aderenza terapeutica e permettendo agli operatori sanitari di intervenire con raccomandazioni più frequenti e mirate. A questo si aggiunge la significativa riduzione dei costi legati al personale, agli spostamenti e ai ricoveri ospedalieri, nonché la grande adattabilità della telemedicina, che può essere impiegata in contesti e per bisogni molto differenti.
Sul fronte delle debolezze, emerge l’elevata dipendenza dalla tecnologia: l’efficacia dell’intervento è strettamente legata alla disponibilità di infrastrutture digitali adeguate e alla capacità di utilizzo da parte di utenti e operatori. Inoltre, permangono alcune limitazioni cliniche, come l’impossibilità di effettuare esami obiettivi o di instaurare un rapporto empatico attraverso il contatto diretto, aspetti che possono influenzare negativamente la qualità percepita dell’assistenza. È inoltre necessario prevedere interventi formativi per professionisti e pazienti, al fine di rafforzare le competenze digitali e garantire un uso consapevole ed efficace degli strumenti. Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla difficoltà di integrazione della telemedicina con i sistemi informativi sanitari esistenti, ostacolando una piena interoperabilità dei dati.
Le opportunità che si aprono con l’adozione della telemedicina sono molteplici. Essa contribuisce a un approccio più sostenibile e “green”, riducendo l’impatto ambientale derivante dagli spostamenti e dalle strutture fisiche. Offre inoltre nuove possibilità per la promozione e la prevenzione della salute, rendendo più costante la presenza del sistema sanitario nella vita del paziente e favorendo una maggiore consapevolezza e aderenza alle cure. L’integrazione con applicazioni per la salute e con altri strumenti digitali amplia il campo d’azione, favorendo anche l’espansione del mercato e l’innovazione nei modelli di servizio. Infine, la telemedicina si allinea perfettamente con le direttrici del PNRR, in particolare con il pilastro dedicato alla digitalizzazione e all’innovazione in sanità.
Non mancano tuttavia alcune minacce. Tra queste, la resistenza al cambiamento sia da parte dei professionisti sanitari che dei pazienti, che potrebbero mostrare riluttanza ad affidarsi a modalità di assistenza virtuale. Le problematiche legate alla cybersecurity – in particolare la protezione dei dati e della privacy – rappresentano un rischio concreto, così come la mancanza di uniformità normativa tra diversi contesti nazionali, che può ostacolare una diffusione omogenea del modello. Infine, l’incertezza economica e l’assenza, in alcuni casi, di modelli di rimborso strutturati rendono più complesso l’avvio del progetto, soprattutto in fase iniziale, quando gli investimenti sono consistenti.
In conclusione, l’analisi evidenzia come l’integrazione della telemedicina nel progetto Homcology rappresenti una soluzione efficace per rafforzare l’assistenza domiciliare oncologica. Non si tratta solo di una risposta concreta alle sfide attuali, ma anche di un’evoluzione coerente con una visione futura della sanità, orientata a un sistema più equilibrato, resiliente e capace di adattarsi ai bisogni di salute di una popolazione in continua trasformazione.
Bibliografia
- Kidholm K, Ekeland AG, Jensen LK, et al. A model for assessment of telemedicine applications: MAST. Int J Technol Assess Health Care 2012;28(1):44-51
- Istituto Nazionale di Statistica. Annuario statistico Italiano 2023
- AIRC. I numeri del cancro 2024