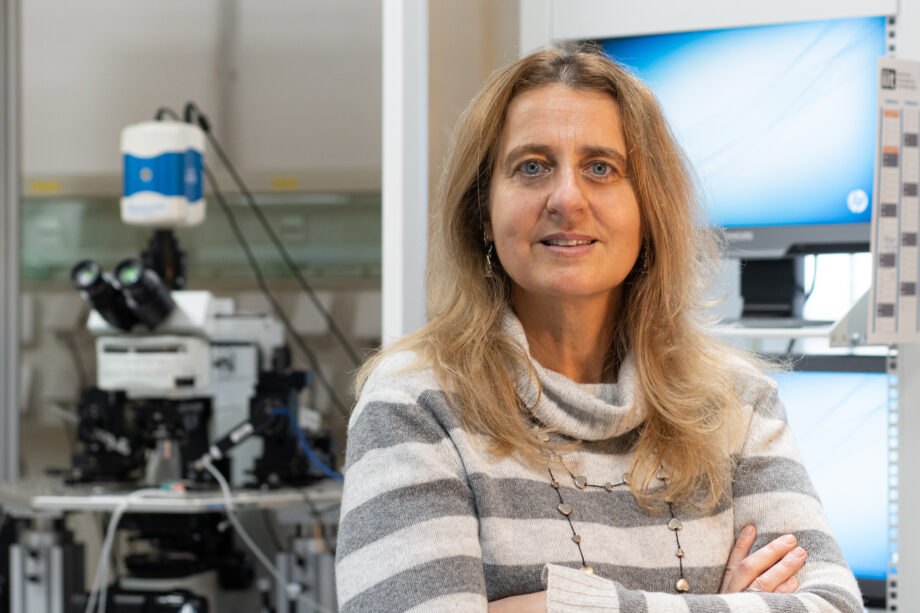La salute delle donne cambia volto: oggi non è più intesa solo in senso funzionale, ma come un equilibrio tra mente e corpo, in cui il benessere psicologico assume un ruolo centrale. Tuttavia, permane una certa insoddisfazione nella gestione della propria salute e nel supporto ricevuto da famiglia e Servizio Sanitario Nazionale. È quanto emerge dalla ricerca di Elma Research, realizzata con Fondazione Onda ETS, che in occasione del suo ventennale confronta i dati attuali con quelli della prima indagine del 2005, delineando come, negli ultimi vent’anni, sia mutato il rapporto delle donne con la propria salute e con il sistema sanitario.
«Nel nostro ventesimo anniversario celebriamo l’attenzione e la dedizione di Fondazione Onda ETS nell’affermare l’importanza della medicina di genere in Italia, ponendo sempre al centro le persone e il loro diritto alla salute – dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS. Le tematiche affrontate negli anni sono state molteplici, ivi inclusa un’attenzione alla violenza contro le donne. Ricerche, attività editoriali, un Congresso annuale multidisciplinare nonché iniziative con gli ospedali con il Bollino Rosa e Azzurro hanno consentito l’avvicinamento della popolazione alle tematiche di salute. L’indagine che abbiamo svolto ha evidenziato quanto per le donne italiane la salute rimane una priorità mutando però la visione, ora più centrata sul benessere globale. A distanza di 20 anni la valutazione della loro salute rimane stabile, riportando ancora oggi criticità su cui spesso, purtroppo, non molto è cambiato: maggiore attenzione alla prevenzione primaria e secondaria, ma minor supporto percepito da parte del SSN nella gestione della salute propria e dei familiari, scarsa conoscenza degli scopi e delle strutture della medicina territoriale, sono alcuni aspetti emersi dalla ricerca. Questo anniversario vuole sottolineare anche un impegno per un futuro in cui la salute di genere diventi parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e in cui ogni donna e ogni uomo possano accedere a cure eque, sostenibili e rispettose delle differenze. Solo così potremo costruire una sanità davvero inclusiva, giusta e capace di promuovere il benessere di tutti», conclude la presidente Merzagora.
Fondazione Onda ETS promuove informazione e prevenzione per una salute di genere più consapevole
Fondazione Onda ETS promuove, dalla sua nascita, una corretta informazione sui temi della salute di genere, ponendo il focus sull’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica nelle malattie a maggior impatto epidemiologico. E oggi, come ieri, l’obiettivo è, quanto mai, continuare a diffondere consapevolezza e informazione alla società a 360 gradi. Ed è per questo che ribadisce con forza, a 20 anni dalla sua istituzione, il costante impegno nella medicina di genere, offrendo, con questa nuova indagine trasversale, una riflessione sul panorama della salute in Italia, sugli atteggiamenti, le modalità di gestione, il supporto percepito, il livello di soddisfazione e il grado di informazione delle donne sul tema della salute.
«I dati presentati oggi ci dicono con chiarezza che la salute, intesa come equilibrio tra corpo e mente, resta una priorità assoluta per le donne, ma che troppo spesso le risposte del nostro Servizio Sanitario non sono ancora adeguate e capaci di tenere conto delle differenze di genere. Le donne chiedono più spazio per sé stesse, più attenzione al benessere psicologico, più prevenzione e più sostegno nella gestione familiare: sono istanze che la politica non può ignorare. Il ventennale di Fondazione Onda ETS ci ricorda quanta strada è stata fatta, ma anche quanto ancora resta da fare per tradurre la medicina di genere in un approccio realmente strutturale, dentro il SSN e nelle politiche pubbliche. Il nostro impegno deve essere quello di costruire una sanità equa, inclusiva, attenta ai bisogni specifici delle persone e capace di mettere al centro la salute delle donne come valore per l’intera società», afferma la Senatrice Daniela Sbrollini, Vicepresidente Commissione Xª Affari Sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale, Senato della Repubblica.
Le donne chiedono più spazio per sé stesse, più attenzione al benessere psicologico, più prevenzione e più sostegno nella gestione familiare
Dalla ricerca di Elma Research, presentata durante un evento in Senato su iniziativa della Senatrice Sbrollini, che ha coinvolto 802 donne di età compresa tra i 18 e i 64 anni, emerge quanto la salute, intesa come un equilibrio psico-fisico da curare e tutelare, rimanga oggi per le donne, a 20 anni di distanza, una priorità assoluta. Gli obiettivi della vita delle donne oggi assumono sfumature differenti, con un incremento dell’attenzione verso i propri interessi e i piaceri della vita: emerge soprattutto il desiderio di avere più spazio per la propria vita personale. La visione della salute diventa più olistica: non solo una donna su due crede che la salute significhi essere in armonia con se stessa, con il proprio corpo e la propria mente, ma la maggior parte ritiene che la propria salute sia legata all’ambiente in cui si vive e alle azioni che si intraprendono. La crescente attenzione al tema della salute ha portato a mettere in campo comportamenti proattivi più sani, come la pratica abituale di attività fisica e un’attenzione maggiore alla prevenzione e al consulto di specialisti.
Sebbene lo stato di salute complessivo venga percepito come sostanzialmente stabile, le donne si dichiarano meno soddisfatte, e spesso preoccupate, della loro forma fisica e del benessere psicologico. Stress e disturbi psichici sono le problematiche più diffuse, in particolare per le giovani tra i 18 e i 35 anni. «Già anni fa un’indagine rivelò come le donne temessero più la depressione che il tumore al seno: da allora Fondazione Onda ETS ha posto la salute mentale tra le sue priorità. Depressione, ansia, disturbi del sonno e alimentari, più frequenti nel genere femminile, sono stati al centro di progetti di ricerca, campagne di sensibilizzazione e iniziative di formazione per medici e cittadini. Fondazione Onda ha promosso il riconoscimento precoce del disagio, abbattuto lo stigma e favorito percorsi di cura inclusivi, contribuendo anche alle Raccomandazioni Nazionali sulla presa in carico della depressione. Da sempre costruisce reti tra Istituzioni, società scientifiche e cittadini, con strumenti come gli Open Day degli ospedali Bollino Rosa e materiali divulgativi. Oggi il suo nuovo impegno guarda al contrasto della solitudine, una crescente minaccia per la salute mentale, grazie anche al Bollino RosaVerde e all’impegno delle farmacie territoriali», afferma Claudio Mencacci, Presidente comitato tecnico scientifico Fondazione Onda ETS.
Stress e disturbi psichici sono le problematiche più diffuse, in particolare per le giovani tra i 18 e i 35 anni
Cresce l’attenzione e il coinvolgimento delle donne verso la salute, non solo propria ma anche, in moltissimi casi, quella dei propri familiari (è il 69 per cento a doversene occupare). Allo stesso tempo la donna si trova più sola rispetto al passato, sempre meno supportata oggi, rispetto al 2005, dai propri familiari nel gestire il proprio bisogno di salute (-14 per cento), percependo, per di più, un Sistema Sanitario Nazionale distante e con servizi poco attenti alle tematiche legate alla sfera femminile. Ciò spinge spesso a consultare specialisti in regime privato, identificando così nel fattore economico la prima barriera nell’accesso a visite, soprattutto preventive. Il livello informativo viene percepito come non adeguato e sufficiente (solo 1 donna su 3 si considera abbastanza/molto informata). Sono molte a utilizzare i social media (26 per cento) e internet (46 per cento) come canali informativi sulla salute, anche se i medici sono ancora comunque ritenuti il canale preferenziale. I canali online complessivamente non sono ritenuti come un reale punto di riferimento su tematiche così delicate quando si tratta di avere informazioni di valore.
«Fondazione Onda ETS ha anticipato di anni il dibattito sulla medicina di genere, mettendo al centro la salute femminile non solo per le patologie tipicamente legate alle donne, ma anche per quelle che colpiscono entrambi i sessi con maggiore incidenza nelle donne. Da questa visione nacque il Bollino Rosa, che ha migliorato i servizi sanitari per le donne. Rimane però fondamentale approfondire le diverse fasi della vita femminile — pubertà, età fertile, menopausa e senescenza — per garantire cure mirate. Il benessere delle donne è essenziale per la salute della società intera», afferma Alberto Costa, Vice-Presidente Fondazione Onda ETS.
La medicina di genere promuove una sanità più equa, attenta a differenze biologiche e socioculturali
«Ormai sappiamo come la medicina di genere rappresenti un’evoluzione cruciale per una sanità più equa ed efficace, superando i tradizionali standard esclusivamente maschili. Questo approccio non si limita alle differenze biologiche, ma considera anche il genere come costrutto socioculturale, influenzando prevenzione, diagnosi e percorsi di cura. Tra questi anche la comunicazione: messaggi troppo generici infatti, possono favorire barriere culturali e psicologiche, costituendo un ostacolo al diritto/dovere per le donne di mantenersi in salute. In questo contesto, non posso che esprimere la mia gratitudine a Fondazione Onda ETS: il costante impegno della Fondazione, in questi 20 anni ha contribuito in modo significativo a sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenere la ricerca e integrare una prospettiva di genere nel Servizio Sanitario Nazionale, promuovendo così una realtà sempre più tangibile e necessaria per la salute di tutti», conclude l’Onorevole Ilenia Malavasi, Componente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati.
L’iniziativa è svolta con il contributo incondizionato di Astellas, Korian, Lundbeck, Novartis, Teva, Viatris e Yakult, con il contributo di Fondazione Cariplo.